"Il mio nome è Asher Lev" 8 - Le difficoltà e le domande
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
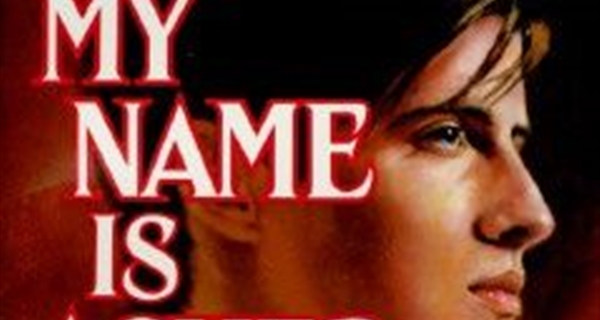
Jacob Kahn
Il Rebbe non abbandonerà più il fanciullo e gli metterà accanto Jacob Kahn, il grande pittore e scultore, che gli farà da maestro nel suo studio, gli consiglierà di studiare La strage degli Innocenti di Guido Reni, il Davide di Michelangelo, le Crocifissioni bizantine e occidentali, le opere di Picasso.
Lo convincerà a visitare i più importanti Musei del mondo in Italia e in Francia, gli farà ritrarre modelle nude, anche se vietato dalla cultura dell’ebreo osservante, gli aprirà la strada per le prime affermazioni e mostre.
Le difficoltà
Ma per Asher ogni passo sulla via dell’arte è difficile, incontra ostacoli, incertezze che deve superare, provocato e al tempo stesso sostenuto dal suo maestro, che lo spinge a non mentire mai a se stesso e all’arte, pur procedendo nell’incomprensione e nella critica di chi lo circonda e di chi egli ama.
"Tu hai un dono, Asher Lev. Hai una responsabilità". Si fermò davanti a me.
"Sai che cos'è questa responsabilità?" Non dissi nulla
"Dimmi cosa pensi che sia questa responsabilità", disse.
"Senti di essere responsabile nei confronti di qualcuno? Di qualcosa?"
“Della mia gente" dissi esitante.
"Quale gente?"
"Gli ebrei"
"Gli ebrei" ripeté "Perché pensi di essere responsabile verso gli ebrei?"
"Tutti gli ebrei sono responsabili l'uno per l'altro" dissi citando l'affermazione del Talmud che anni prima mio padre aveva citato a me.
"Come artista, sei responsabile verso gli ebrei?" Sembrava adirato. "Ascoltami, Asher. In quanto artista non sei responsabile verso niente e nessuno tranne te stesso e la verità come la vedi tu. Capisci? Un artista è responsabile verso la sua arte"(pagg.187,188)
Dopo qualche tempo i genitori si trasferiscono stabilmente a Vienna ed egli annuncia con decisione di non volerli seguire.
Andrà a vivere dallo zio Yzchok che sposterà la sua stanza da disegno nel grande atrio messo a disposizione per il nipote.
Il Rebbe lo segue da lontano e gli invia la sua benedizione, imponendogli al momento di iscriversi al liceo ladover, di studiare il francese. Solo dopo molto tempo Asher scoprirà che la sua conoscenza sarà fondamentale quando si trasferirà in Francia.
Le Domande
Nell’ultima parte del romanzo il protagonista si trova solo davanti al conflitto più potente di tutti, che si agita dentro di lui e lo scuote, al dubbio di appartenere o no con la sua arte al regno delle tenebre.
“E’ male fare qualcosa quando non si sa nemmeno che lo si sta facendo?”
(pag.113)
“Se tu non vuoi che io usi questo dono, perché me lo hai dato?" Aveva chiesto una volta rivolgendosi a Dio. “Era spaventoso pensare che il mio dono potesse essermi stato dato da una fonte malefica e abietta. Come possono il male e l’abiezione creare un dono di bellezza? (pag.107)
“Non avevo fatto del male a nessuno”(pag. 237), ripeteva.
Perché dunque incontrava tanta incomprensione e ostilità?
“Non cercare di capire” gli dice Jacob Kahn .”Diventa un grande artista: è l’unico modo di giustificare ciò che fai alla vita di tutti”
(pag. 237)
Queste parole lo ossessionano , ma allo stesso tempo lo richiamano alla verità dell’arte, alla bellezza che in essa traluce, che non può essere opera del Maligno e che quindi non può essere tradita.
Con le prime mostre arrivano i primi riconoscimenti e successi. Lui diventerà un grande artista, e non rinnegherà il dono ricevuto.
Ma gli incontri con i genitori si fanno sempre più rari e l’incomprensione più profonda.
Il Rebbe lo convoca di nuovo un giorno nel suo ufficio:
“Cosa posso dirti mio Asher? Non so cosa abbia in serbo per noi il Padrone dell’Universo. Alcune cose sono date, ed è compito dell’uomo utilizzarle per portare la bontà nel mondo: Il Padrone dell’Universo ci dà qualche barlume, solo barlumi.
Tocca a noi aprire bene gli occhi…Ti auguro una vita lunga e sana, figlio mio.
Ti do la mia benedizione per la grandezza nel mondo dell’arte e la grandezza nel mondo della tua gente” (pag. 243).
Andrà a Firenze, a Roma, a Parigi, dove si trasferirà; inizierà ad essere conosciuto e apprezzato, vivendo per lo più lontano dai suoi e studiando e ridisegnando le grandi opere di Vermeer, dei pittori francesi dell’’800 e del primo ‘900, di Chagall, degli artisti visti alla Cappella Sistina, al Louvre e al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, dove si commuove davanti al Davide e alla Pietà di Michelangelo.
E lo stesso Potok ha parlato della straordinaria impressione ricevuta dalla vista della Pietà:
“Anni fa stavo conducendo una ricerca, per il terzo libro che ho scritto, Il mio nome è Asher Lev. A Firenze ho visto la Pietà di Michelangelo, non dimenticherò mai quell'esperienza: ho visto delle fotografie della Pietà, ma avvicinarmi a quella pietra, e vederla come viva, con l'agonia di quella madre, con quella drammaticità incredibile nella vostra storia, è stata ancora una volta un'esperienza che mi ha completamente sopraffatto, e questo è stato un contatto con il trascendente, del quale ho scritto nel romanzo . (...)”(Incontro al Meeting di Rimini, 1999):
Quando nel romanzo Asher si trova davanti alla Pietà afferma:
Sentii la pena e il dolore racchiusi in quella pietra. Ero un ebreo osservante eppure quel blocco di pietra mi attraversò come un grido… Ero capace solo di metterla in relazione con la mia vita passata”
Lo strazio della morte di Cristo ossessiona il protagonista: nessuna forma artistica della sua tradizione si può avvicinare al dramma della Crocifissione e della deposizione e dopo la loro visione molteplici immagini si sovrappongono nella sua mente: mentre schizza i personaggi della scultura, ripensa al tormento provato dalla madre per tanti anni, quando appoggiata alla sbarra verticale della finestra aspettava ansiosamente il figlio e il padre, amati entrambi ed entrambi nutriti dal suo amore.
Ora pensavo a mia madre e cominciai a percepire qualcosa dei suoi anni di angoscia. Il mezzo fra due differenti modi di dare significato al mondo, e allo stesso tempo assillata dalle sue paure dai suoi ricordi, si era avvicinata ora me, ora mio padre, tenendo in vita tutti e due i mondi di significato, nutrendo, nonostante i suoi tormenti, con il suo minuscolo essere sia me che mio padre. Aveva tenuto in vita il dono durante quegli anni morti; aveva tenuto in vita se stessa riprendendo il lavoro di suo fratello morto e aveva tenuto in vita mio padre, consentendogli di riprendere i suoi viaggi. Intrappolata fra due regni di significato, si era destreggiata fra l'uno e l'altro, nutrendo e alimentando entrambi, oltre a se stessa."(pag.276)
Nella sua mente quel ricordo si fonde con lo stesso dolore lacerante del Cristo sacrificato della Pietà e delle Crocifissioni, rappresentate dalla iconografia cristiana e censurate dalla cultura ebraica.
