«Nel Papa il vero riferimento»
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
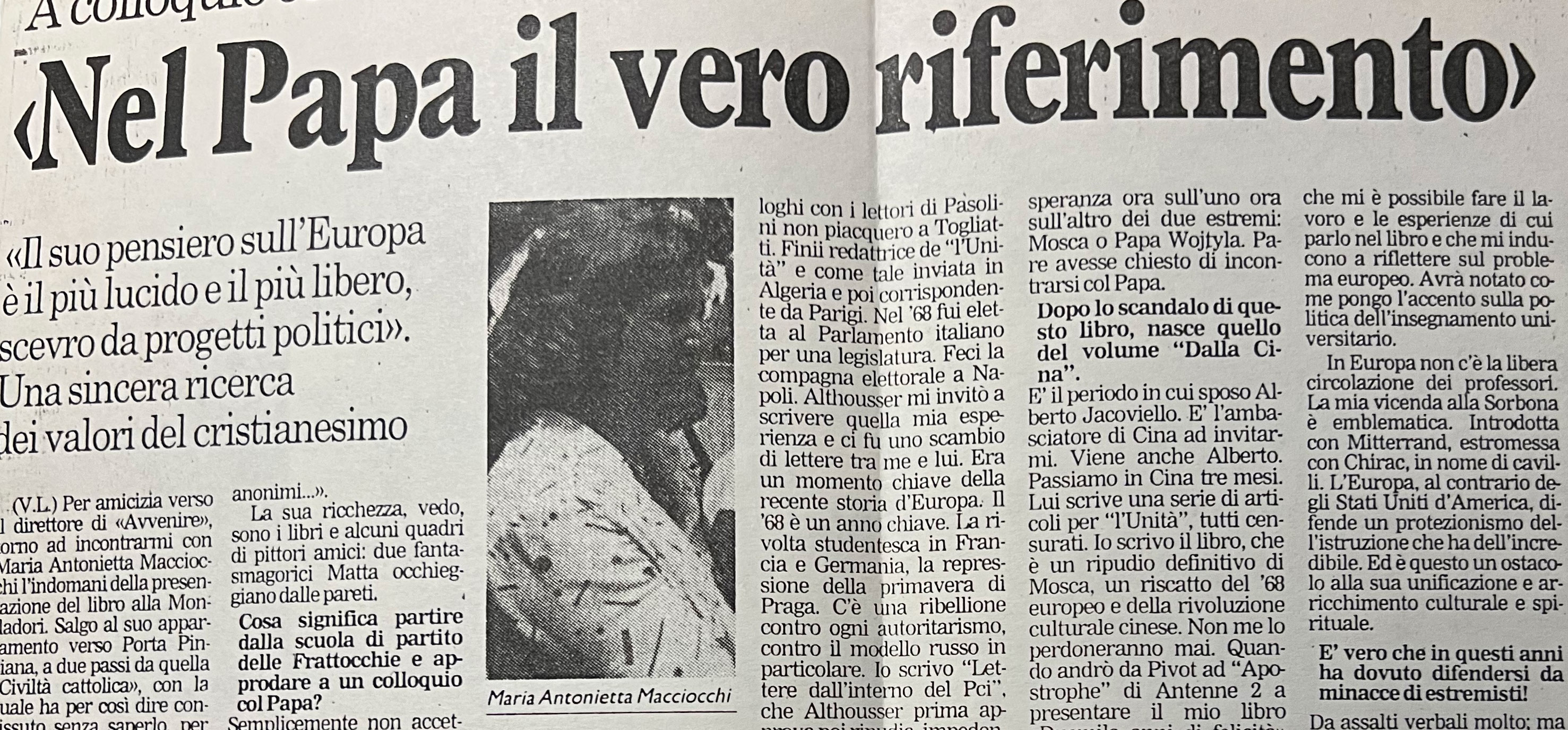
A colloquio con l’autrice del libro “Di là dalle porte di bronzo. Viaggio intellettuale di una donna in Europa” sulle prospettive dell’unità
«Nel Papa il vero riferimento»
(V.L.) Per amicizia verso il direttore di «Avvenire», torno ad incontrarmi con Maria Antonietta Macciocchi l’indomani della presentazione del libro alla Mondadori. Salgo al suo appartamento verso Porta Pinciana, a due passi da quella «Civiltà cattolica», con la quale ha per così dire convissuto senza saperlo, per tanti anni. E’ un appartamento luminoso, dignitoso, senza lusso. Quarant’anni di politica non l’hanno arricchita E’ rimasta «la donna con la valigia», che corre da Roma a Napoli, a Salerno, a Parigi, a Bruxelles, al Lussemburgo, in Cina, in Cambogia. Mi vengono in mente quelle righe del suo libro, con cui chiosa una citazione di Julien Benda. Diceva Benda: «L’Europa è un’idea; essa sarà fatta dai credenti nell’Idea e non dagli uomini che hanno un focolare. Gli uomini che hanno fatto la Chiesa non avevano guanciali su cui riposare la testa». E lei: «Mi arrestai di colpo, pensando beffardamente alla mia vita di europea randagia, e ai guanciali estranei su cui poggiavo la testa negli hotel anonimi...».
La sua ricchezza, vedo, sono i libri e alcuni quadri di pittori amici: due fantasmagorici Matta occhieggiano dalle pareti.
Cosa significa partire dalla scuola di partito delle Frattocchie e approdare a un colloquio col Papa?
Semplicemente non accettare il pregiudizio e andare fin dove ti portano l’intuizione e l’ideale.
Ma lei è battezzata? Certo. Vengo da una famiglia italiana normale. Papà era un liberale antifascista. Mamma morì prematuramente a 38 anni. Ci fu in me un rigetto della religione. Mi imbattei in Malraux. «La condition humaine» ha segnato la mia vita. Ho scoperto l’esistenza delle masse, la loro povertà. Al liceo ho conosciuto il comunismo. Collaboravo a «l’Unità» clandestina. Ho fatto la staffetta partigiana. Mi sono laureata in lettere e ho sposato Pietro Amendola. Sono diventata una propagandista dell’antifascismo tra la gente di Napoli e Salerno. Nel 1948 Pietro è deputato. Faccio la campagna per la Repubblica, contro la monarchia, tra gli insulti delle popolane napoletane. Verso gli anni ’50, anni di fame nera, mi occupo dei bambini napoletani. Ne mandiamo diecimila in Lombardia, in Emilia, in Piemonte, ospiti di famiglie, dove almeno possono sfamarsi. Tutti, poi, troveranno una strada.
Lei è in un certo senso più parigina che romana. Come è finita a Parigi?
Per vicende di partito. Dirigevo ‘Noi donne’ poi venivo designata a dirigere ‘Vie nuove’. Mi sembrava giusto aprile le pagine degli organi di partito a intellettuali di valore anche non integrati. Le corrispondenze di Malaparte dalia Cina, i dialoghi con i lettori di Pasolini non piacquero a Togliatti. Finii redattrice de “l’Unità” e come tale inviata in Algeria e poi corrispondente da Parigi. Nel ’68 fui eletta al Parlamento italiano per una legislatura. Feci la campagna elettorale a Napoli. Althusser mi invitò a scrivere quella mia esperienza e ci fu uno scambio di lettere tra me e lui. Era un momento chiave della recente storia d’Europa. Il ’68 è un anno chiave. La rivolta studentesca in Francia e Germania, la repressione della primavera di Praga. C’è una ribellione contro ogni autoritarismo, contro il modello russo in particolare. Io scrivo “Lettere dall’interno del Pci”, che Althusser prima approva poi ripudia, impedendomi di pubblicare in Francia la sua parte di corrispondenza.
Il povero Althusser, massimo teorico francese del marxismo, era ormai preda di crisi violentissime, di cui ha reso testimonianza recentemente Jean Guitton sul periodico “Lire”. Aveva vicino a sè un cane da guardia dell’ortodossia che era sua moglie, che riusciva a impedirgli di manifestare l’oscillazione negativa del pendolo. Ma la conseguenza fu l’uxoricidio. Secondo Guitton, Althusser si rendeva conto che da una parte la religione, la fede si faceva più razionale, dall’altra il razionalismo si faceva sempre più dogmatico. Era preso in questo intreccio, che spingeva la sua speranza ora sull’uno ora sull’altro dei due estremi: Mosca o Papa Wojtyla. Pare avesse chiesto di incontrarsi col Papa.
Dopo lo scandalo di questo libro, nasce quello del volume “Dalla Cina”.
E’ il periodo in cui sposo Alberto Jacoviello. E’ l’ambasciatore di Cina ad invitarmi. Viene anche Alberto. Passiamo in Cina tre mesi. Lui scrive una serie di articoli per “l’Unità”, tutti censurati. Io scrivo il libro, che è un ripudio definitivo di Mosca, un riscatto del ’68 europeo e della rivoluzione culturale cinese. Non me lo perdoneranno mai. Quando andrò da Pivot ad “Apostrophe” di Antenne 2 a presentare il mio libro «Duemila anni di felicità» sarò insultata e aggredita moralmente per quel libro lontano.
E come passa dalla politica militante all’insegnamento universitario?
Nel 1972 vado all’Università di Vincennes per un corso su Gramsci. Nel ’77 sostengo la mia tesi in scienze politiche alla Sorbona e ottengo una cattedra a Parigi 8.
E’ allora che Pannella bussa alla mia porta. Sono molto riluttante a tornare alla politica attiva. Comunque non entrerò più in alcun partito. Accetto di concorrere come indipendente alle elezioni nazionali ed europee del 1979. Opto per il Parlamento europeo, dove rimango per una legislatura. Dapprima nel gruppo radicale, poi, dall’81, in quello socialista. E’ nel Parlamento europeo che mi è possibile fare il lavoro e le esperienze di cui parlo nel libro e che mi inducono a riflettere sul problema europeo. Avrà notato come pongo l’accento sulla politica dell’insegnamento universitario.
In Europa non c’è la libera circolazione dei professori. La mia vicenda alla Sorbona è emblematica. Introdotta con Mitterrand, estromessa con Chirac, in nome di cavilli. L’Europa, al contrario degli Stati Uniti d’America, difende un protezionismo dell’istruzione che ha dell’incredibile. Ed è questo un ostacolo alla sua unificazione e arricchimento culturale e spirituale.
E’ vero che in questi anni ha dovuto difendersi da minacce di estremisti!
Da assalti verbali molto; ma qualche volta anche da intimidazioni. In un periodo del ’78 ho dovuto rifugiarmi in casa di amici parigini, per sentirmi al sicuro.
Nella sua ricerca per un futuro unitario europeo, quale considera il riferimento più solido?
Quello di Karol Wojtyla. Lo dico da un punto di vista culturale. Trovo che il suo pensiero sull’Europa sia il più lucido, il più motivato, il più libero, senza preconcetti né intenzioni surrettizie. E’ uno che ha vissuto un’esperienza di libertà interiore a confronto diretto con la tirannide stalinista, dopo aver sperimentato quella nazista. Lui sa come si difende un popolo aggredito da ogni parte: aggrappandosi alla sua identità culturale. Così ha fatto la Polonia per secoli. L’aggressione non è solo militare e non è solo nazionale. Può essere ideologica e continentale. Può essere l’aggressione della dissoluzione: la tentazione dei particolarismi.
Il Papa è convinto che l’Europa non ha tanto bisogno di un progetto politico particolare, quanto di una rianimazione del suo spirito, e delle sue radici. Sa quanto si attende l’Est dall’Occidente. E quanto l’Occidente se ne sia dimenticato. E’ la memoria storica che va ravvivata. E un’azione conseguente.
Nel capitolo che parla del suo viaggio a Castel Gandolfo, lei parla a lungo del Papa. O meglio, lo pensa. Pensa a quello che fa e dice e a come reagisce l’opinione pubblica. Lei contrappone ad ogni giudizio negativo e minimizzante un suo giudizio positivo, una giustificazione, una spiegazione. Si tratta dell’ennesima posizione controcorrente rispetto a un certo andazzo della cultura laicistica?
Certamente, ma con motivazioni. E’ facile e comodo forse criticare il Papa. Può anche diventare una moda. Io osservo e trovo che la sua linea di azione è culturalmente motivata e coerente. Tanto mi basta.
Dalle sue pagine traspare una profonda emozione per l’incontro con il Papa; più di quanto potrebbe accadere a un credente. Come si spiega?
Non si spiega.
Com’è approdata fino al Papa?
Grazie a monsignor Silvestrini. Parlando con lui, ho trovato una serenità e una bontà che mi erano sconosciuti. Sembrava sapere tutto, capire tutto. Una bontà rispettosa. Per una storia turbinosa. Mi ha incoraggiato a scrivere il libro. Mi ha dato fiducia a chiedere l’udienza del Papa.
Posso augurarle che la sua ricerca dei valori del cristianesimo non finisca qui?
Volentieri. E la ringrazio.
