Presenza o utopia
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
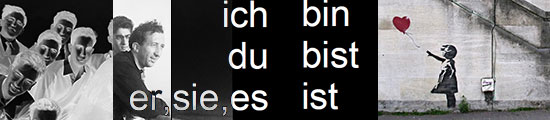
Capita, in questi tempi, di sentire alcuni richiami alla presenza cristiana che sanno tanto di fideismo o di “quietismo”; per questo ho ripreso quanto ho imparato nel movimento, da don Giussani.
Sarà importante rileggere tutto il testo “Dall’utopia alla presenza” in cui egli sottolinea la grande questione, con la nota che spiega la ragione per cui ci ha sempre richiamato con forza e passione. «Quanto ho detto è una insistenza metodologica, non l’abolizione di una responsabilità. Ho indicato ciò che deve accadere affinché noi abbiamo a lavorare di più, a incidere di più nella realtà, e in una letizia sempre più grande, non in un logorio e in una amarezza che ci dividono gli uni dagli altri. Il compito che ci aspetta è l’espressione di una presenza consapevole, capace di criticità e di sistematicità. Tale compito implica un lavoro.
Il lavoro è il porsi della nostra identità dentro la materialità del vivere . La mia identità , in quanto penetra la materialità del vivere, cioè in quanto è dentro la condizione esistenziale, lavora e mi fa reagire. Se io sono in macchina e devo andare in fretta in un luogo, ma in mezzo alla strada c’è un sasso che non mi permette di passare, ecco che la mia “identità di automobilista” diventa lavoro: curvo, accosto, prendo il sasso e lo sposto».
Così diventa estremamente chiaro quello che ci è chiesto perché la nostra presenza sia incidente e costruttiva, e noi non abbiamo a logorarci, ma a vivere intensamente.
Ancora mi faccio aiutare dalle parole di don Giussani, agli inizi della nostra storia:
«1) La prima condizione per raggiungere tutti è una iniziativa chiara di fronte a chiunque.
2) Può essere illusione ambiguamente coltivata quella di introdursi nell’ambiente o di proporsi alle persone con una indecisione tale da sminuire il richiamo, nel timore che il suo urto contro la mentalità corrente indisponga gli altri verso di noi, e crei insormontabili incomprensioni e solitudini.
Si possono così cercare, magari con ansiosa scaltrezza, accomodamenti e camuffamenti che rischiano troppo facilmente di rappresentare dei compromessi dai quali è poi assai arduo liberarsi.
3) Non dobbiamo dimenticarci che questa “mentalità corrente” non esiste solo al di fuori di noi, ma ci permea fin nel profondo. Per cui l’indecisione nell’affrontarla può costituire una posizione rovinosa per noi stessi.
4) Per essere onesti, ad un certo momento occorre porsi di fronte ai problemi seri, non solo nell’ambito interiore della propria coscienza, ma anche nel dialogo con gli altri.
5) Per questo occorre la forza di mettersi contro, che è quanto Cristo ci ha chiesto per farci entrare nel Regno: “Chi avrà avuto vergogna di me di fronte agli uomini, anch’io avrò vergogna di lui di fronte al Padre mio”.
6) Forza, cioè coraggio (“virtus”, in latino): in fondo ciò che occorre è un po’ di quella virtù con cui Matteo, Zaccheo e la Maddalena affermarono la loro scoperta cristiana di fronte all’ambiente in cui erano immersi.
O, se si vuole, ciò che occorre è rinnovare la testimonianza di Stefano di fronte al Sinedrio: sfidare l’opinione di tutti per seguire Gesù». [GS: Riflessioni sopra una esperienza]
Questo spiega perché, anche in queste vacanze, siamo stati così attivi: non per una mania di protagonismo, nella illusione che sia il nostro “fare” a risolvere le situazioni, ma per la responsabilità di una presenza, nella certezza che l’ambiente nel quale siamo inseriti ci chiede un lavoro e un giudizio, che esprima la nostra identità di comunione. Quella comunione che, ultimamente, ci ha fatto incontrare a Cortina d’Ampezzo per raccontare – dentro un contesto “laico” – «quello che abbiamo di più caro», e che ci rende capaci di «esaminare ogni cosa, trattenendone il valore».
Ne abbiamo provato un gusto indicibile!

