Sarà tutto inevitabile?
- Curatore:
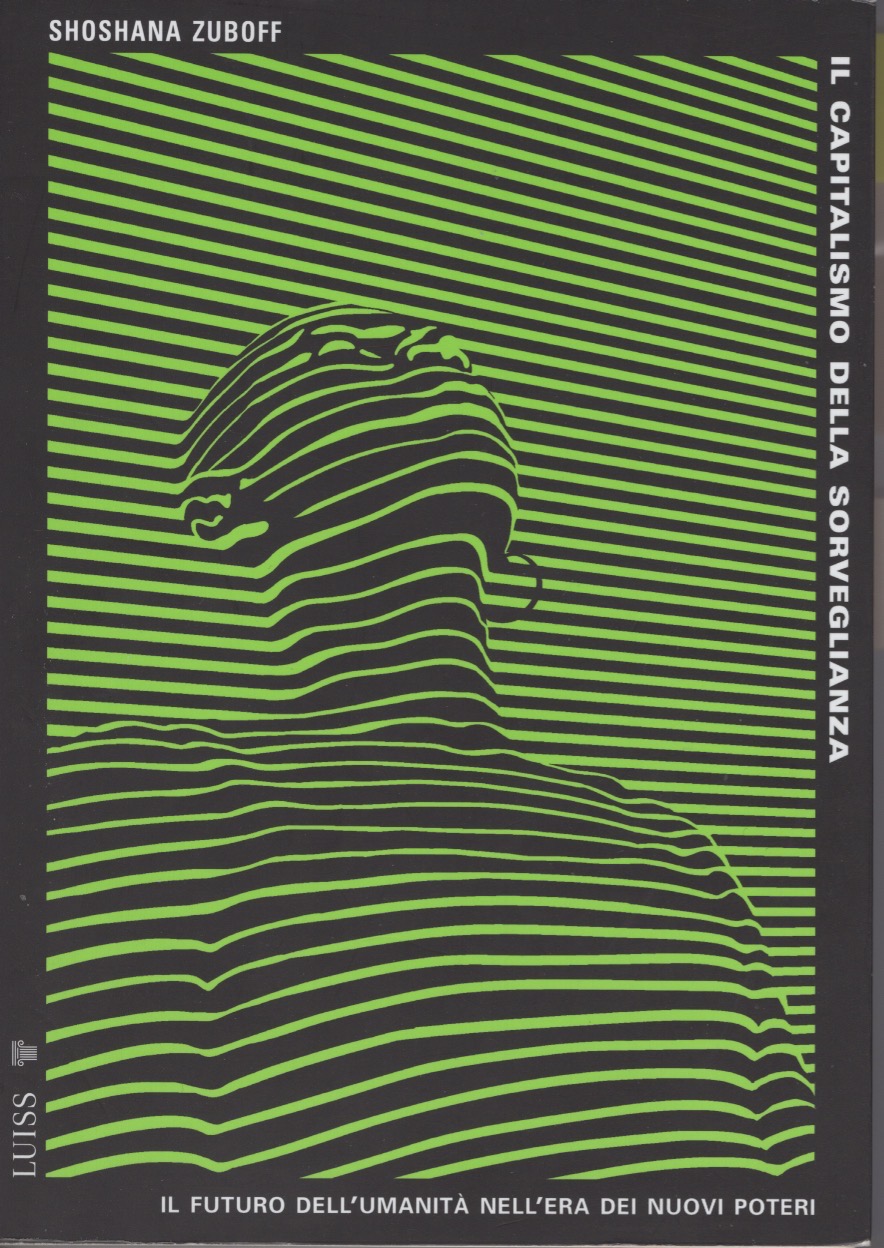
Immagina di avere un martello. Rappresenta l’apprendimento delle macchine. Ti è servito per scalare una montagna impervia e arrivare fino in cima: la montagna è la conquista dei dati online. Sulla cima della montagna trovi un cumulo di chiodi, più a buon mercato di qualunque altra cosa tu possa immaginare. Rappresentano la nuova tecnologia dei sensori smart. Ai tuoi piedi si estende a perdita d’occhio una tavola di legno nuova e infinita. È il mondo muto attorno a noi. Impari che ogni volta che pianti un chiodo puoi ricavare del valore da quella tavola che prima era inerte. Questa è la monetizzazione dei dati. Che cosa fai? Cominci a martellare come un pazzo, senza fermarti mai, a meno che qualcuno non ti faccia fermare. Ma qui non c’è nessuno che ci faccia fermare. Ecco perché “l’internet di tutto” è inevitabile.
UNA CREAZIONE UMANA
Il martellare incessante del credo inevitabilista pone l’ubiquità del nuovo apparato come il prodotto di forze tecnologiche che operano al di fuori delle possibilità umane e delle scelte delle comunità, un movimento implacabile che nasce fuori dalla storia e spinge in una direzione che in qualche modo conduce alla perfezione della specie e del pianeta. L’immagine della tecnologia come una forza autonoma che agisce con risultati inevitabili è stata impiegata spesso nel corso dei secoli per cancellare le impronte digitali del potere e assolverlo da ogni responsabilità. È stata colpa del mostro, non di Victor Frankenstein. Non è però il braccialetto alla caviglia a monitorare il prigioniero, è il sistema penitenziario.
Ogni dottrina dell’inevitabilità porta con sé un virus armato, fatto di nichilismo morale, programmato per mirare all’azione umana e cancellare resistenza e creatività dalle risposte possibili. La retorica dell’inevitabilità è una truffa che ci rende inerti e passivi al cospetto di forze implacabili che sono e devono sempre essere indifferenti a quel che è meramente umano. Siamo nel mondo delle interfacce robotizzate, dove le tecnologie mettono in atto la loro volontà e proteggono i potenti da ogni sfida.
Nessuno l’ha espresso in modo più profondo e sintetico di John Steinbeck all’inizio del suo capolavoro, Furore, quando descrive i contadini affamati sfrattati dalle loro case in Oklahoma, durante la Grande Depressione, che si dirigono a Ovest, in California. Le famiglie sono costrette a lasciare le terre delle quali si sono occupate per generazioni. Cercano di difendersi con i delegati della banca mostrando quanto siano inermi. Ma i delegati rispondono che “la banca è qualcosa di diverso dagli uomini. Tanto è vero che ogni uomo che lavora per una banca odia profondamente quello che la banca fa, e tuttavia la banca lo fa ugualmente. Credetemi, la banca è più degli uomini. È il mostro. Gli uomini la creano, ma non possono controllarla”.
Il tema della presupposta autonomia tecnologica è sempre stato tenuto in grande considerazione dagli studiosi. Ancora una volta, Langdon Winner può farci da guida, ricordandoci che una delle caratteristiche della vita moderna è accettare la tecnologia senza fare domande: “I cambiamenti e i disagi portati ripetutamente da una tecnologia in via d’evoluzione nella vita moderna sono stati accettati come un dato di fatto, o come inevitabili, semplicemente perché nessuno si è preso la briga di chiedere se ci fossero altre possibilità’’.
Winner osserva che abbiamo accettato di “adeguarci” a uno schema di “deriva” tecnologica, definita come “l’accumulo di conseguenze inattese”. Accettiamo che la tecnologia non debba essere ostacolata per il bene della società, e in tal modo ci arrendiamo al determinismo tecnologico. Considerare in modo razionale le implicazioni sociali viene considerato da “retrogradi”, scrive Winner, “e non il prezzo che la tecnologia scientifica fa pagare alla civilizzazione. […] Ancora oggi, ogni proposta di limitare in qualche modo l’avanzamento tecnologico [...] viola un tabù fondamentale. [...] Accettiamo invece il cambiamento, guardandoci alle spalle per vedere che cosa abbiamo fatto solo dopo, soltanto per curiosità”. Alla “curiosità” di Winner aggiungerei un’altra cosa: il rimorso.
I leader del capitalismo della sorveglianza presumono che ci arrenderemo alla fallacia naturalistica proprio come erano costretti a fare i contadini di Steinbeck. Se Google ha successo - e in effetti il capitalismo della sorveglianza ha successo - allora le sue regole devono senz’altro essere buone e giuste. Come i nuovi delegati della banca, Google vuole farci accettare che le sue regole non facciano altro che riflettere le esigenze di processi autonomi, qualcosa di incontrollabile per le persone. Comprendendo la logica interna del capitalismo della sorveglianza, possiamo capire che la realtà è un’altra: è stato creato da uomini e donne che potrebbero controllarlo, ma che hanno semplicemente scelto di non farlo.
L’inevitabilismo presenta come un progresso l’apparato dell’ubiquità, ma nasconde la realpolitik del capitalismo della sorveglianza che opera dietro le quinte. Noi sappiamo che ci sono vie alternative percorribili da un sano capitalismo dell’informazione in grado di offrire soluzioni adatte a una terza modernità. Abbiamo visto come il capitalismo della sorveglianza sia stato scoperto e perfezionato con gli anni, fabbricato da uomini e donne al servizio del capitale impaziente. La stessa logica oggi richiede l’ubiquità, ed è pronta a colonizzare i progressi della tecnica a beneficio della propria crescita e dei propri imperativi. L’inevitabilismo agisce al servizio di tali imperativi, distogliendo l’attenzione dalle ambizioni di un ordine economico in ascesa e dalle ansie che spingono il progetto di sorveglianza verso la certezza e il conseguente bisogno di un’appropriazione ancor più famelica dei nostri comportamenti.
L’inevitabilismo esclude la scelta e la partecipazione volontaria. Non lascia spazio alla volontà umana come autrice del futuro. Pertanto nascono degli interrogativi: in che momento la pretesa inevitabilista che estrazione ed esecuzione debbano essere ubique sconfina nell’abuso? Le utopie inevitabiliste evocheranno nuove forme di coercizione pensate per tenere calmi quei popoli che non rinunceranno a volere scegliere il proprio futuro?
(Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, pp238-240)
