E’ risuscitato e continua a vivere
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
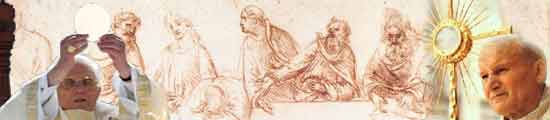
«Nell’originale kerigma (annuncio), trasmesso di bocca in bocca, merita di essere segnalato l’uso del verbo “è risuscitato”, invece del “fu risuscitato” che sarebbe stato più logico utilizzare, in continuità con “morì… e fu sepolto”. La forma verbale “è risuscitato” è scelta per sottolineare che la risurrezione di Cristo incide sino al presente nell’esistenza dei credenti: possiamo tradurlo con “è risuscitato e continua a vivere” nell’Eucaristia e nella Chiesa. Così tutte le Scritture rendono testimonianza della morte e risurrezione di Cristo, perché – come scriverà Ugo di San Vittore – “tutta la divina Scrittura costituisce un unico libro e quest’unico libro è Cristo, perché tutta la Scrittura parla di Cristo e trova in Cristo il suo compimento” (De arca Noe, 2,8). Se sant’Ambrogio di Milano potrà dire che “nella Scrittura noi leggiamo Cristo”, è perché la Chiesa delle origini ha riletto tutte le Scritture d’Israele partendo da e tornando a Cristo”. La scansione delle apparizioni del Risorto a Cefa, ai Dodici, a più di cinquecento fratelli, e a Giacomo si chiude con l’accenno alla personale apparizione, ricevuta da Paolo sulla strada di Damasco: “Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto” (1 Cor 15,8). Poiché egli ha perseguitato la Chiesa di Dio, in questa confessione esprime la sua indegnità nell’essere considerato apostolo, sullo stesso livello di quelli che l’hanno preceduto: ma la grazia di Dio accomuna Paolo ai primi testimoni della risurrezione di Cristo: “Sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto” (1 Cor 15,11). E’ importante l’identità e l’unicità dell’annuncio del Vangelo: sia loro sia io predichiamo la stessa fede, lo stesso Vangelo di Gesù Cristo morto e risorto che si dona nella Santissima Eucaristia» [Benedetto XVI, Udienza Generale, 24 settembre 2008].
Relazione tra san Paolo e gli Apostoli che lo avevano preceduto nella sequela di Gesù
Questi rapporti furono sempre segnati da profondo rispetto e da quella franchezza che a Paolo derivava dalla difesa della verità del Vangelo. Anche se egli era, in pratica, contemporaneo di Gesù di Nazaret, non ebbe mai l’opportunità d’incontrarlo, durante la sua vita pubblica. Per questo, dopo la folgorazione sulla strada di Damasco, avvertì il bisogno di consultare i primi discepoli del Maestro, che avevano vissuto con Lui ed erano scelti da Lui perché ne portassero il Vangelo cioè la narrazione dei fatti e detti divino – umani del percorso terreno cioè i misteri del Risorto che continua a viverli, a renderli liturgicamente, sacramentalmente attuali in ogni luogo e in ogni tempo, in particolare nell’Eucaristia e nel vissuto fraterno di comunione ecclesiale autorevolmente guidato e questo sino ai confini del mondo.
Nella Lettera ai Galati Paolo stilla un importante resoconto sui contatti trattenuti con alcuni dei Dodici: anzitutto con Pietro che era stato scelto come Kephas, la parola aramaica che significa roccia, su cui si stava edificando la Chiesa (Gal 1,18), con Giacomo, “il fratello del Signore” (Gal 1,19), e con Giovanni (Gal 2,9): Paolo non esita a riconoscerli come “le colonne” della Chiesa. Particolarmente significativo è l’incontro con Cefa (Pietro), verificatosi a Gerusalemme: Paolo rimase presso di lui 15 giorni per “consultarlo” (Gal 1,19), ossia per essere informato sulla vita terrena del Risorto, che lo aveva “ghermito” sulla strada di Damasco, gli aveva dato una nuova vita, uno nuovo spazio di esistenza tanto da assimilarlo a Lui memorizzando liturgicamente tutto il percorso terreno tanto da divenire “uno in Cristo” (Gal 3,28), un unico soggetto nuovo, liberato dal suo isolamento da poter dire “io, ma non più io” e gli stava cambiando, in modo radicale l’esistenza con un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva della “novità” cristiana chiamata a trasformare la storia e il mondo: da persecutore nei confronti della Chiesa di Dio era diventato evangelizzatore, missionario della presenza del Messia risorto in lei e nell’Eucaristia, in ogni cristiano, che in passato aveva cercato di uccidere e di distruggere (Gal 1,23).
La Tradizione, cioè il tramandare in continuità dagli Apostoli, è lo strumento più grande nella comunicazione del vero nella vita della Chiesa
Quali genere di informazioni Paolo ebbe su Gesù Cristo nei tre anni che succedettero all’incontro di Damasco cioè all’inizio dell’essere cristiano? Nella prima Lettera ai Corinzi possiamo notare due brani, che Paolo ha conosciuto a Gerusalemme, Chiesa Madre, e che erano stati già formulati come elementi centrali della tradizione cristiana, lo strumento più grande della comunicazione del vero nella vita della Chiesa nella sua stessa continuità fin dagli Apostoli. Egli li trasmette verbalmente prima dello scritto ispirato, così come li ha ricevuti, con una formula molto solenne, il primo simbolo apostolico: “Vi trasmetto quanto anch’io ho ricevuto”. Insiste cioè sulla fedeltà a quanto egli stesso ha ricevuto e che fedelmente trasmette ai nuovi cristiani. La Tradizione è la coscienza della comunità che vive nell’attualità la memoria di tutta la sua vicenda storica. Sono elementi costitutivi nella gerarchia delle verità di fede e concernono l’Eucaristia e la Risurrezione; si tratta di brani già formulati negli anni trenta. Arriviamo così alla morte, sepoltura nel cuore della terra e alla risurrezione di Gesù (1 Cor 15,3-4). Prendiamo l’uno e l’altro:
- le parole di Gesù nell’Ultima Cena (1 Cor 11,23-35) sono realmente per Paolo centro della vita della Chiesa: la Chiesa cioè il vissuto fraterno di comunione ecclesiale autorevolmente guidato si edifica a partire da questo centro, diventando così se stessa cioè il Corpo di Cristo risorto. Oltre questo centro eucaristico, nel quale nasce sempre di nuovo la Chiesa – anche per tutta la teologia di San Paolo, per tutto il suo pensiero – queste parole hanno avuto un notevole impatto sulla relazione personale di Paolo con Gesù. Da una parte attestano che l’Eucaristia illumina la maledizione della croce, rendendola benedizione (Gal 3,13-14), e dall’altra spiegano la portata della stessa morte e risurrezione di Gesù. Nelle lettere il “per voi” dell’istituzione eucaristica diventa il “per me” (Gal 2,20), personalizzando come richiede l’atto di fede, sapendo che in quel “voi” lui stesso era personalmente conosciuto e amato da Gesù e dall’altra parte “per tutti” (2 Cor 5,14): questo “per voi” diventa “per me” e “per la Chiesa (Ef 5,25), ossia anche “per tutti” del sacrificio espiatorio della croce (Rm 3,25). Dalla e nell’Eucaristia la Chiesa si edifica e si riconosce quale “Corpo di Cristo” (1 Cor 12,27), alimentato ogni giorno dalla potenza dello Spirito di Cristo.
- L’altro testo, sulla Risurrezione, ci trasmette di nuovo la stessa formula di fedeltà. Scrive San Paolo: “Vi ho trasmesso dunque, anzitutto quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici” (1 Cor 15, 3-5). Anche in questa tradizione trasmessa a Paolo torna quel “per i nostri peccati”, che pone l’accento sul dono che Gesù ha fatto di sé al Padre per liberarci dai peccati e dalla morte e quindi dalla schiavitù di Satana e dei suoi “satelliti”. Da questo dono di sé, Paolo trarrà le espressioni più coinvolgenti e affascinanti del nostro rapporto con Cristo: “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio” (2 Cor 5,21); “Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9). E il Santo Padre ricorda il commento col quale l’allora monaco agostiniano, Martin Lutero, accompagna queste espressioni paradossali di Paolo: “Questo è il grandioso mistero della grazia divina verso i peccatori: che con un mirabile scambio i nostri peccati non sono più nostri, ma di Cristo, e la giustizia di Cristo non è più di Cristo, ma nostra” (Commento ai salmi del 1513 – 1515). E così siamo salvati.
L’importanza che Paolo conferisce alla Tradizione viva della Chiesa, che trasmette alle sue comunità, dimostra quanto sia errata la visione di chi attribuisce a Paolo l’invenzione del cristianesimo: prima di evangelizzare Gesù Cristo, il suo Signore, egli l’ha incontrato sulla strada di Damasco e lo ha frequentato nella Chiesa, osservandone la vita nei Dodici e in coloro che lo hanno seguito per le strade di Galilea. La stessa missione, carisma specifico di Paolo ricevuto dal Risorto in ordine all’evangelizzazione dei gentili, ha bisogno di essere riconosciuta, confermata e garantita da coloro che diedero a lui e a Barnaba la mano destra, in segno di approvazione del loro apostolato e della loro evangelizzazione e di accoglienza nell’unica comunione della Chiesa di Cristo (Gal 2,9). Si comprende allora che l’espressione “anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne” (2 Cor 5,16) non significa che la sua esistenza terrena abbia uno scarso rilievo per la nostra maturazione nella fede e per la nostra assimilazione a Lui nella memorizzazione e attualizzazione liturgica, bensì che dal momento della sua Risurrezione e del nostro incontro sacramentale con Lui, cambia il nostro modo di rapportarci con Lui: non solo un ricordo, una esemplarità storica da imitare ma la Persona di Gesù Cristo, presente nella via umana della Chiesa, da incontrare oggi (oggi Cristo è nato, è battezzato nel Giordano, è andato ad uno sposalizio in Galilea…) e da cui lasciarsi assimilare. Egli è, nello stesso tempo il Figlio di Dio, presente ieri, oggi e sempre come Ragione creativa, “nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti” con il “salto” decisivo verso una dimensione di vita profondamente nuova che riguarda Gesù di Nazaret e con Lui noi, tutta la famiglia umana, la storia e l’intero universo.
Quanto più cerchiamo di rintracciare le orme storiche di Gesù di Nazaret per le strade della Galilea, tanto più le rendiamo liturgicamente attuali nel vissuto fraterno di comunione ecclesiale autorevolmente guidato, tanto più possiamo comprendere che Egli si è fatto e si fa carico di tutta la nostra umanità, condividendola in tutto, tranne che nel peccato. La nostra fede non nasce da un mito, né da un solo ricordo, né da un’idea, bensì dall’incontro con il Risorto nella vita della Chiesa.
