Sfida del discernimento o sfida al discernimento?
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
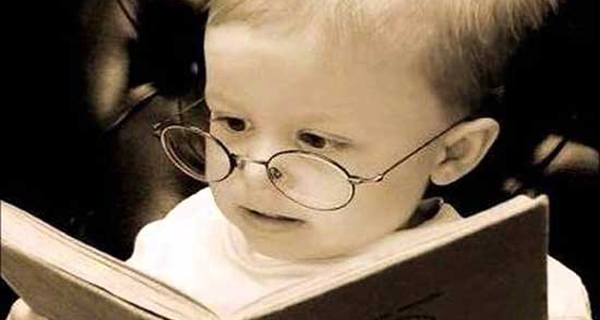
[Seguito]
Scrivono Spadaro – Cameli in “La sfida del discernimento in Amoris laetitia”: “ogni processo di discernimento porta ad una conversione” e citano Guardini, unico punto chiaro di tutto lo scritto, che tratta appunto della coscienza, ma è pericoloso lasciare solamente per implicito che ogni processo di discernimento deve avvenire secondo retta coscienza.
Purtroppo, nella prospettiva di Spadaro – Cameli, il discernimento evita di esaminare la persona o la situazione alla luce della verità e della legge e di giudicarla astrattamente “dall’esterno”, confrontandola con un modello estraneo, nella pretesa di ricondurla all’ordine morale ed ecclesiale. Per contro, il discernimento spadariano s’impegna a esaminare la persona o la situazione “dall’interno”, alla luce della sua coscienza, cogliendo la persona nelle sue esigenze, al fine di valutarla nella sua autenticità vissuta.
Si dice che questo metodo permetta di salvare nelle persone e situazioni ciò che comunque resterebbe in loro di sincero e di valido, in modo da giudicarle dando preminenza non ai fatti ma alle intenzioni, non al male compiuto o non riparato ma al bene residuo o potenziale.
Osservo che la norma morale non è un criterio esterno o, peggio, estraneo al soggetto da giudicare. La legge divina, che si esprime nella legge naturale e nella legge evangelica, viene partecipata dalla nostra ragione, che la percepisce, nella coscienza, come esigenza o inclinazione della natura umana a compiere quegli atti, effetti volontari di giudizi pratici e prudenziali, che la conducono al conseguimento del suo fine, ossia della sua perfezione e della felicità.
La legge morale perviene all’uomo certamente dall’esterno, è appresa come un dato oggettivo, perché non è invenzione umana o un’emanazione del soggetto, ma è comando divino, che parla alla coscienza. È trovata in quella natura che l’uomo non si è fatta da sé, ma che è creata da Dio. Ma è preciso compito della ragion pratica e della coscienza interiorizzarla, farla propria, scoprirla come intima ed insopprimibile esigenza e tendenza del proprio io, sorgente di giustizia, di bontà e di felicità.
Come si esprime Mosè facendo parlare Dio: “Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,11.14)
Queste inclinazioni pratiche, ossia della volontà, al bene e in ultima analisi a Dio, apprese dalla ragione nello studio della natura umana ed avvertiti dalla coscienza di tutti (“sinderesi”), sono universali, immutabili ed insopprimibili in ogni uomo, perché appartengono alla natura umana come tale.
Esse certo sono formulate in giudizi, concetti e comandi astratti: né diversamente potrebbe essere, perché la ragione umana non può concepire il reale, sia statico che dinamico, l’essere e l’agire, se non astrattamente. Ma ciò non vuol dire che la legge morale sia un’astrazione (ens rationis). Al contrario, essa invece, sia pur nella forma astratta del concetto, è in se stessa un’inclinazione reale della natura. Ed è vero altresì che la legge va applicata nel concreto dell’azione della persona singola.
Quando dunque Spadaro oppone legge universale a coscienza singola, e quindi il comando astratto della legge al dettato della coscienza singola sotto pretesto che l’azione è nella concretezza del vissuto e non nell’astrazione delle idee, dà mostra di confondere la legge con l’applicazione della legge e di contrapporre illecitamente, per conseguenza, l’universale al singolare.
In realtà, nell’agire umano, l’astratto discende nel concreto. L’ideale deve incarnarsi nel reale. L’uno e l’altro non hanno contenuti diversi, ma sono il medesimo contenuto o valore pratico, prima nell’ordine del pensiero e poi tradotto nei fatti.
Il singolare non può evadere dall’universale, perché questo ne è il fondamento di intellegibilità e legittimità, ma deve starvi dentro, perché star fuori della legge non è, come crede Rahner “superare la legge”, ma semplicemente contravvenire alla legge. La situazione non può essere fonte della legge, ma è la legge che dev’essere applicata nelle modalità suggerite dalla situazione.
Infatti, Rahner ha una teoria sbagliata dell’applicazione della legge. Egli nega che sia sufficiente applicare il principio in quanto astratto, ma che, per assicurare la concretezza e l’adattamento dell’azione, occorre che il soggetto aggiunga un’ulteriore ultima determinazione a seconda delle situazioni. In tal modo egli sostituisce l’universalità della legge con la decisione singola del soggetto, che esprime in un atto categoriale – giudizio concettuale – l’opzione fondamentale.
Per lui, quindi, non esistono leggi universali, immutabili e indispensabili, perché il soggetto, a seconda delle situazioni, a giudizio della propria coscienza, può “superare” la legge per attuare l’“opzione fondamentale”, ossia quella che egli chiama “autotrascendenza verso Dio”.
Da questa errata impostazione derivano massime e slogan talismanici di una certa importanza e successo: accompagnamento, integrazione, ascolto, dialogo, “situazioni complesse”, coppie e famiglie “imperfette”, ecc..
Non potendo affrontare per questioni di spazio – tempo, tutti questi inganni linguistici mi concentro su un paio che prendo dal libro di Vignelli «Una rivoluzione pastorale»:
• “situazioni complesse”
Per definizione, l’aggettivo complesso significa risultante dall’unione di varie parti o elementi interdipendenti, per cui indica una realtà di difficile comprensione o classificazione.
Tuttavia, nel nuovo linguaggio ecclesiale, per situazioni complesse s’intendono semplicemente le situazioni ritenute irregolari o immorali, la cui problematicità richiede una diagnosi e una terapia circostanziate. Ne sono un noto esempio le coppie composte da conviventi o da divorziati-risposati. L’inganno linguistico sta nel definire una situazione usando un aggettivo eufemistico (complesso) che ne nasconde proprio quell’aspetto irregolare o immorale che pure ne sta all’origine e ne permette la valutazione etica. È infatti noto che, quando si ha timore di chiamare qualcosa col suo nome, si ricorre a eufemismi e giri di parole. Nel nostro caso, se ne conclude che tale situazione non può essere giudicata né risolta in modo netto. E così, la complessità diventa un pretesto per eludere il problema ed evitarne la cura risolutiva ma spiacevole.
• Coppie e famiglie “imperfette”
Il discernimento pastorale esige che le coppie o famiglie ferite non siano più criticate come immorali e nemmeno come irregolari, ma solo valutate come imperfette.
Per definizione, imperfetto significa incompiuto, manchevole e perciò difettoso. Ma ci sono diversi tipi d’imperfezioni: alcune sono leggere e scusabili, perché non danneggiano l’integrità del soggetto (ad esempio della famiglia), mentre altre sono gravi e inescusabili, perché lo danneggiano fino a rovinarla.
Fidando nelle indagini sociologiche e nella propaganda mass-mediatica, la nuova pastorale inclina a credere che ormai sia difficilissimo trovare coppie o famiglie perfette in ogni aspetto; pertanto, un sano realismo richiede di rassegnarsi alla crescente prevalenza di coppie e famiglie imperfette, con le quali la società e la Chiesa stessa debbono pur convivere.
Anche qui, il cambio eufemistico dell’aggettivo (da immorale a irregolare e poi a imperfetto) favorisce un cambio non solo di sensibilità o di stile ma anche di valutazione morale, come al solito in senso permissivo e tendenzialmente assolutorio. D’altra parte, dato che nel mondo nulla è davvero perfetto, chi mai oserebbe condannare qualcuno per il solo fatto di essere “incompiuto, manchevole o difettoso” in qualcosa?
Orbene, è ovvio che nessuna coppia o famiglia è perfetta in tutto, come lo fu esemplarmente la Famiglia di Nazareth. Tuttavia, ad esempio, una coppia che vive in stato scandaloso di concubinato non può essere qualificata come meramente imper- fetta, ma dev’essere giudicata come immorale in quanto pubblica peccatrice. Se ci si limita a classificarla come imperfetta e a compatirla come vittima, si fa torto innanzitutto alla verità e alla giustizia, ma poi anche alla coppia in questione, che da questo linguaggio si sentirà, se non giustificata nel suo peccato, almeno sminuita nella sua responsabilità, col rischio di finire confermata nel male.
Alla fine, le coppie o famiglie irregolari saranno non solo scusate ma anche accettate “così come sono”, ossia giustificate nella loro immoralità, con conseguente grave danno per il senso morale e per il bene comune della società e della Chiesa. E così, si sarà passati dal tollerare il male ad accettarlo come normale.
La distanza tra la pastorale nuova e quella classica possiamo misurarla leggendo questo ammonimento di un Papa non certo severo:
«È preferibile che il parroco, invece di usare parole dolci e accondiscendenti, in un severo colloquio con i concubini li esorti a non commettere un così grave delitto e a non peccare contro la legge divina» (Pio VII, Etsi fraternitatis, lettera dell’8-10-1803)
Spadaro sembra ridurre il peccaminoso all’imperfetto o al semplice difetto. Invece è molto importante fare la distinzione. La differenza, in fondo, è semplice, anche se occorrono precisazioni: l’imperfetto è un bene; il peccato è un male. L’imperfetto si concilia con la buona volontà; il peccato è cattiva volontà. Il peccato e l’imperfezione sono difetti, ossi mancanza di un bene necessario. L’uno e l’altra suppongono un soggetto buono per altri versi. Ma il peccato è un difetto volontario, mentre non lo è necessariamente l’imperfezione. Il peccatore, in quanto peccatore, resiste al bene; invece l’imperfetto desidera migliorare.
L’imperfetto può essere corretto o tollerato o migliorato; il peccato dev’essere semplicemente tolto. Per esempio, nell’uso delle gambe, lo zoppicare è un’imperfezione nella deambulazione. Ma se uno dà un calcio ad un altro, non parliamo più di imperfezione, ma di una brutta azione, che va riparata.
L’imperfetto è il bene involontariamente incompiuto; il peccato è ciò che è volontariamente fatto male. L’“Incompiuta”di Schubert è una grande sonata e nessuno farà un rimprovero a Schubert per questa sua opera; ma se un sacerdote per pigrizia o infedeltà lascia incompiuto il suo ministero, questo è peccato.
Nel campo della virtù l’imperfezione involontaria è cosa comunissima. Sono rarissimi coloro che hanno virtù perfette. Paolo stesso riconosce di non essere perfetto, ma di tendere alla perfezione. La perfezione di quaggiù è appunto il tendere alla perfezione; il che vuol dire che si è sempre imperfetti. Ma ciò non toglie che si possa essere grandi santi.
Ma ciò è cosa ben diversa dal peccato e dal vizio, che possono bensì essere imperfezioni, ma lo sono volontariamente. Il peccatore non tende alla perfezione, ma va contro la perfezione. Così, per esempio, una coppia di divorziati risposati non è una coppia imperfetta; è una coppia peccatrice.
Per concludere, lo scritto di Spadaro – Cameli più che una sfida del discernimento è una sfida al discernimento… del loro stesso testo! Testo che somma confusione a confusione…
