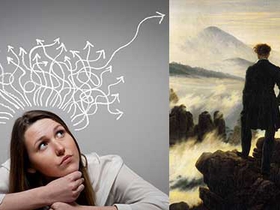“La sfida del discernimento in Amoris laetitia”
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
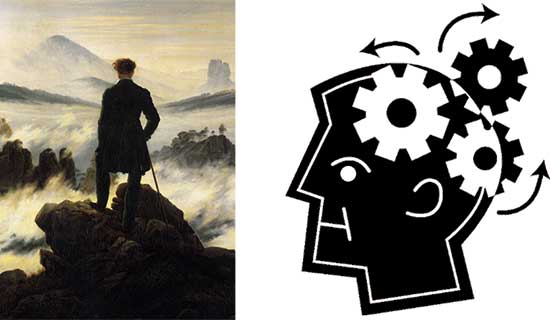
Caro don Gabriele,
dopo avere letto il lungo articolo di Spadaro e di Cameli “La sfida del discernimento in Amoris laetitia”, ho avvertito subito una nota stonata, che è precisamente questa: un’eccessiva dilatazione di significato al vocabolo, senza distinguerne pienamente il senso. Questo provoca un pericoloso cortocircuito nella relazione essenziale tra concetto e parola che si esprime. La relazione, non più univoca tra vocabolo e concetto, genera, giocoforza, confusione.
La prima cosa che ho fatto è stato controllare il significato del termine, sia laico nel vocabolario, sia religioso nel Catechismo. In quest’ultimo al termine discernimento non è data tutta quell’importanza che ha oggi (Spadaro afferma che “discernimento” è citato circa 50 volte in Amoris laetitia): viene citato solamente 11 volte ai seguenti punti: 407 – 801 – 1676 –1729 – 1780 – 2690 – 2820 – 2846 – 2847 – 2863 e mai messo al centro di un punto specifico o di un paragrafo come per esempio la coscienza morale.
Occorre, per prima cosa, distinguere tra discernimento morale e discernimento spirituale.
Per definizione, il discernimento morale è la facoltà di formulare un giudizio, o di scegliere un comportamento, in conformità alle esigenze della situazione; il che permette di giudicare persone e fatti al fine di unire ciò che va unito e di dividere ciò che va diviso. Insomma, per fare la scelta giusta serve il discernimento morale, che è la capacità di valutare i termini di una questione, i caratteri di una situazione, così da poter operare scelte corrette, oculate. Le nostre scelte dovrebbero essere sempre prudenti (Virgo prudentissima, ora pro nobis). È scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC n. 1806):
La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per compierlo. […] E’ la prudenza che guida immediatamente il giudizio di coscienza. L’uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio. Grazie alla virtù della prudenza applichiamo i principi morali ai casi particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene da compiere e sul male da evitare”.
Proprio così! Per applicare i principi morali ai casi particolari è necessaria la prudenza e l’uomo prudente decide e ordina la propria condotta seguendo il giudizio di coscienza. Come si vede, si torna sempre al giudizio di coscienza, non può esistere vero discernimento senza la retta coscienza, che è quello che conta, perché
nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente parla alle orecchie del cuore... L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al suo cuore... La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 16] (CCC 1776).
Rilievo importantissimo: la coscienza morale è un giudizio della ragione. È scritto nel CCC 1778:
La coscienza morale è un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta compiendo o ha compiuto. In tutto quello che dice e fa, l’uomo ha il dovere di seguire fedelmente ciò che sa essere giusto e retto. E’ attraverso il giudizio della propria coscienza che l’uomo percepisce e riconosce i precetti della legge divina: La coscienza è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza... la messaggera di Colui che, nel mondo della natura come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo [John Henry Newman, Lettera al Duca di Norfolk, 5]”.
Tutto questo prevede il cammino di formazione della retta coscienza. Semplicemente dire “cammino di discernimento”, invece, non è sufficientemente chiaro!
Infatti, per diventare uomini e donne di fede (e non solo) è d’importanza primaria la formazione della propria coscienza sin dai primi anni di vita, perché l’educazione della coscienza garantisce la libertà e genera la pace del cuore. Senza la coscienza, niente libertà. Bellissimo il n. 1784 del Catechismo:
L’educazione della coscienza è un compito di tutta la vita. Fin dai primi anni dischiude al bambino la conoscenza e la pratica della legge interiore, riconosciuta dalla coscienza morale. Un’educazione prudente insegna la virtù; preserva o guarisce dalla paura, dall’egoismo e dall’orgoglio, dai risentimenti della colpevolezza e dai moti di compiacenza, che nascono dalla debolezza e dagli sbagli umani. L’educazione della coscienza garantisce la libertà e genera la pace del cuore.
Senza una coscienza buona e pura non è possibile essere misericordiosi. Infatti, “Infatti la carità “sgorga”, ad un tempo, “da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera” (CCC n. 1794).
Tutti questi profondi e bellissimi significati, Spadaro – Cameli li condensano nel discernimento, ma non distinguono sufficientemente, anzi non distinguono affatto, tra discernimento morale e discernimento spirituale. In effetti, essi intendono sempre discernimento spirituale: “L’obiettivo del discernimento è conoscere la volontà di Dio nelle particolari circostanze della propria vita in modo da abbracciarla e viverla come meglio si può”. Niente da eccepire. Il problema, però, è che Spadaro tende a metterlo in contrapposizione con il discernimento morale. Scrive Spadaro:
“Guardare, attendere, osservare” […] “A questo punto non è necessario «fare» alcunché con ciò che abbiamo ascoltato e osservato. Sono essenziali la paziente attesa e lo sguardo uniti all’ascolto attento, e quindi il consentire che gli elementi della vita e della chiamata giungano a maturare e a mettersi a fuoco.
Maturare e mettersi a fuoco da soli? Magicamente senza alcun insegnamento, necessario alla formazione della retta coscienza?
Spadaro sbaglia nel contrapporre il discernimento alla soluzione dei problemi. Scrive Spadaro:
Il problem solving impiega risorse razionali per giungere ad una soluzione. […] In ognuna di queste azioni esiste un chiaro prima e dopo. In un certo momento la diagnosi, il problem solving e l’analisi trovano una soluzione. Per il discernimento la circostanza è diversa.
Il presupposto del discernimento è che esso non riguarda [la soluzione di] un problema, ma piuttosto una vita in cammino, una persona che procede sulla strada verso Dio.
Il discernimento, in generale, nel campo della guida delle anime, è l’attitudine dell’educatore a dare una valutazione prudente, con retta coscienza, in base a solidi princìpi morali ed alla conoscenza della situazione e della condotta morale del soggetto, delle sue qualità e dei suoi difetti, chiedendo eventualmente luce allo Spirito Santo, al fine di dargli o un orientamento di vita o di consigliarlo, istruirlo, aiutarlo, stimolarlo, ammonirlo o incoraggiarlo in circostanze particolari, o per risolvere qualche problema o qualche dubbio, che gli venga posto dal soggetto, correggendolo dai suoi difetti e facendolo avanzare nella virtù.
E’ bene che la guida, se le riesce, guardi e consideri la persona nel suo complesso e nel senso della sua vita – e qui Spadaro ha ragione –. Ha invece torto nello scindere il discernimento dall’affrontare i problemi concreti e dal dovere della guida, per quanto gli è possibile, sia di fornire princìpi e direttive di fondo, sia di dare soluzioni e indicazioni concrete, precise e sicure, alla luce della scienza morale, della Scrittura, dell’insegnamento dei Santi e del Magistero della Chiesa.
L’educatore, però, non deve comandare il soggetto a bacchetta, o scrutarlo e controllarlo nell’intimo della sua vita interiore, come se il soggetto fosse un robot, ma, dopo averlo illuminato con sani princìpi di ragione e di fede, consentirgli giusti spazi di libertà e di iniziativa autonoma, così come ritiene bene di fare in ascolto della sua coscienza, affidandolo a Dio. Qui Spadaro ha ragione, ma dimentica o glissa sul fatto che la coscienza dev’essere informata dalla norma oggettiva.
[Continua]