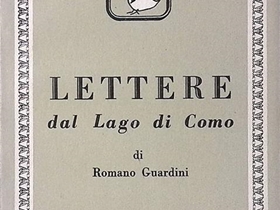Nella scuola, la vita può rimanere vivente...
- Autore:
- Fonte:

Un altro anno scolastico è passato. Che ne è stato del tempo vissuto, delle esperienze fatte, delle conoscenze acquisite? È finita la paura del Covid, con le sue implicazioni, dalla paura del contagio alla solitudine della Didattica a Distanza, con la nostalgia di rapporti veri e la consapevolezza di un «noi» con cui affrontare la vita e le sue tematiche.
Quando ci siamo incontrati con gli insegnanti di religione per un momento di scambio di esperienze, è emersa una situazione variegata, dove è sembrato più ferito il mondo degli adolescenti, più che il cammino dei più piccoli.
Certo, sembra che la scuola e l’educazione dei giovani non sia, purtroppo, tra i temi di discussione e di confronto abituali. Si è parlato della scuola quando una Dirigente ha impedito la benedizione pasquale, e si sono invocati astratti principi di laicità per cancellare questa bella tradizione. Forse la parola più drammatica è proprio quel «cancellare», che, nei paesi d’oltre oceano, sta assumendo forme insensate di rifiuto di una storia e di una tradizione che ha costituito un onore e una responsabilità di estremo valore.
E, mentre cercavo di raccogliere alcuni pensieri per riprendere quanto quest’anno ci ha insegnato, mi sono imbattuto nel magistrale discorso del Santo Padre rivolto al mondo universitario e della cultura nel suo recente viaggio in Ungheria (tra l’altro penso che tutti i discorsi di quel viaggio vadano ripresi e approfonditi, evitando la penosa riduzione giornalistica che, in cerca dello scoop, non si accorge della realtà).
Il Papa ha ripreso un testo illuminante di Romano Guardini, grande educatore dei giovani, in cui egli riflette su una sua feconda intuizione culturale (e anche qui mi permetto di rimandare i lettori al testo da poco ripubblicato di quelle Lettere dal Lago di Como che costituisce un gioiello di suggerimenti e di indicazioni per il nostro tempo). Così come leggo nella presentazione del mio «vecchio» testo: «È possibile, si chiede Guardini, conseguire un atteggiamento spirituale positivo e comprensivo di fronte agli infiniti aspetti e momenti in cui si manifesta la tumultuosa volontà di rinnovamento tecnico, sociologico, culturale del nostro tempo? È consentito salvare la bellezza, la spontaneità di un passato civile e artistico, di perpetuare i valori di una tradizione, senza venir meno ai compiti costruttivi d’una società ardentemente protesa verso un futuro totalmente diverso?
Come l’uomo oggi può ‘umanizzare’ il suo avvenire e non esserne sopraffatto?»
Perché sta proprio qui la questione che dovrebbe appassionare noi tutti, consapevoli di essere membri di quella Chiesa che s. Giovanni XXIII chiamava Mater et magistra e che s. Paolo VI indicava come esperta in umanità.
E tale preoccupazione ha mosso l’Associazione Accoglienza della Vita di San Marino a proporre un progetto di educazione affettiva e sessuale capace di coinvolgere nel cammino educativo anche coloro che per natura ne sono i diretti titolari, cioè le famiglie (tenuto conto che a San Marino tale educazione, prevista dalla legge che introduce l’aborto come diritto nella Repubblica, è di esclusiva competenza dello stato). Suggerendo queste indicazioni nel contesto di un servizio a tutta la società, nell’ottica di quella sussidiarietà che potrebbe ridurre la pretesa di ogni statalismo soffocante: «Parlare di Educazione affettiva, all’amore significa entrare in proprie visioni dell’Uomo, in questioni etico-morali, non ultimo politiche. Non esiste neutralità: se così fosse, le lezioni riguarderebbero soltanto conoscenze medico-scientifiche. Il fatto che invece siano inserite come obbligatorie e curricolari, significa che stiamo connotando queste lezioni di visioni politiche della sessualità e della educazione. Tali e quali a quelli proposti dall’OMS, stilati da commissioni medico-politiche o politico-giuridiche.
Educare non è solo informare: leggere un fenomeno complesso che permea la persona in crescita, solo con strumenti medico-scientifici, senza confronti o discussioni con la famiglia del bambino/ragazzo non è accettabile.
Si tratta a nostro parere di una linea di intervento che vuole modificare assunti valoriali senza esplicitare il progetto. Citiamo l’OMS “Standard per l’educazione sessuale in Europa” in cui si afferma che bambini e ragazzi devono essere in grado di effettuare scelte che modificano la qualità della loro vita “contribuendo ad una società solidale e giusta”. Queste non sono fonti scientifiche, sono scelte ideologiche, come si esprime la legge “in un’ottica di genere”».
Mi pare che le famiglie, riprendendo la affascinante responsabilità educativa, e mettendosi insieme, potrebbero dare un contributo indispensabile alla scuola, e soprattutto ai giovani, sia ai propri figli che a tutti coloro che usufruiscono del servizio scolastico.
Così Papa Francesco: «Cent’anni fa Romano Guardini… ebbe una feconda intuizione culturale. Scrisse: «In questi giorni ho più che mai compreso che vi sono due forme di conoscenza […], l’una conduce ad immergersi nell’oggetto e nel suo contesto, per cui l’uomo che vuol conoscere cerca di vivere in lui; l’altra, al contrario, raduna le cose, le decompone, le ordina in caselle, ne acquista padronanza e possesso, le domina…
Egli vedeva un grande pericolo: «L’uomo perde tutti i legami interiori che gli procurano un senso organico della misura e delle forme di espressione in armonia con la natura» e, «mentre nel suo essere interiore egli è divenuto senza contorni, senza misura, senza direzione, egli stabilisce arbitrariamente i suoi fini e costringe le forze della natura, da lui dominate, ad attuarli». E lasciava ai posteri una domanda inquietante: «Cosa ne sarà della vita se essa finirà sotto questo giogo? [...] Cosa accadrà […] quando ci troveremo davanti al prevalere degli imperativi della tecnica? La vita, ormai, è inquadrata in un sistema di macchine. […] In un tale sistema, la vita può rimanere vivente?...
La vita può rimanere vivente? È una questione che… è bene porsi. Infatti, quanto intravisto da Guardini appare evidente ai nostri giorni: pensiamo alla crisi ecologica, con la natura che sta semplicemente reagendo all’uso strumentale che ne abbiamo fatto. Pensiamo alla mancanza di limiti, alla logica del “si può fare dunque è lecito”. Pensiamo anche alla volontà di mettere al centro di tutto non la persona e le sue relazioni, ma l’individuo centrato sui propri bisogni, avido di guadagnare e vorace di afferrare la realtà. E pensiamo di conseguenza all’erosione dei legami comunitari, per cui la solitudine e la paura, da condizioni esistenziali, paiono tramutarsi in condizioni sociali. Quanti individui isolati, molto “social” e poco sociali, ricorrono, come in un circolo vizioso, alle consolazioni della tecnica come a riempitivi del vuoto che avvertono, correndo in modo ancora più frenetico mentre, succubi di un capitalismo selvaggio, sentono come più dolorose le proprie debolezze, in una società dove la velocità esteriore va di pari passo con la fragilità interiore…
Ideologie opposte convergono in una omologazione che colonizza ideologicamente. Questo è il dramma, la colonizzazione ideologica; l’uomo, a contatto con le macchine, si appiattisce sempre di più, mentre il vivere comune diventa triste e rarefatto».
Qui, come ricordava il poeta, «c’è un lavoro comune. Una Chiesa per tutti. E un impiego per ciascuno. Ognuno al suo lavoro».