Walter Tevis: Dalla realtà non si sfugge
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
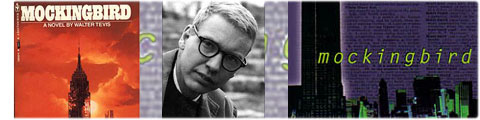
Il permanere nell’immaginario di tanti di noi delle suggestioni (alcune, peraltro, bellissime) di film come Blade Runner, Atto di forza, Matrix, A.I., i club di ammiratori che, numerosi, si riconoscono (fino all’imitazione) nelle saghe di Guerre Stellari e Star Trek, c’impedisce di liquidare, con aristocratica supponenza, il genere fantascienza come pura evasione del nostro tempo per gente (mal) cresciuta.
Cerchiamo di capire: è vero (forse) che la science fiction riscuote tanto successo perché rappresenta l’agognata/temuta/teorizzata “fuga dalla realtà”.
Non c’è da meravigliarsi: «Il genere umano non può reggere troppa realtà» (non è una frase da “replicante” di Dick, ma di T. S. Eliot ne I quattro quartetti).
Messo alla prova dalle alterne vicende di questo mondo, ognuno di noi è tentato di costruire nuovi mondi, a propria misura, a propria immagine e somiglianza, dove il presente, colorato di normalità, possa sfumare in un futuro migliore e nascere da un passato migliorabile (quante e sognate “macchine del tempo”, da Wells a Ritorno al futuro, a cambiare il corso di ciò che è stato e che non ci ha soddisfatto, nel senso etimologico del termine).
Ma se questa è la segreta aspirazione, la nostra umanità (e quindi anche la sua particolare forma di espressione che è la fantascienza) non può evitare la realtà, ma è “costretta” al suo riconoscimento.
Ci soccorre ancora Eliot: «Il tempo passato e il tempo futuro, ciò che avrebbe potuto essere e ciò che è stato, mirano a un solo fine che è sempre presente».
La realtà, il suo “fine”, la misteriosa (ma concreta) traiettoria delle storie e della storia si affacciano, prepotenti, sempre, anche quando la fantasia e la mente fuggono altrove.
Mondi… non perfetti
Allora, anche nella “costruzione dei mondi” (a volte talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono…), negli spazi del futuro affollati di astronavi, stelle e alieni che la fantascienza racconta, s’insinua, drammatica e benefica, la santa inquietudine di sempre, quella domanda di felicità che il cuore dell’uomo conserva e che non si accontenta di risposte parziali.
È una inquietudine che i più avveduti fra gli scrittori di fantascienza (pochi) non riescono ad ignorare, e che fa capolino in qualunque futuro, con drammaticità: una inquietudine che ritroviamo in Simak, in Bradbury, in Dick, in Miller jr, in Sturgeon. E in Walter Stone Tevis, poco prolifico autore noto ai più per il romanzo L’uomo che cadde sulla terra, da cui fu tratto l’omonimo film di Nicolas Roeg, interpretato da David Bowie.
Ma l’opera migliore di Tavis è Futuro in trance (Mockingbird), allucinata visione di un futuro in cui la ricerca della felicità ha imboccato decisamente la strada del rifiuto della realtà.
In una civiltà costruita da ormai estinti “ingegneri sociali” certamente animati da ottime intenzioni, servita (o governata?) dagli automi, il comandamento supremo è costituito dalla cancellazione della memoria, con i suoi corollari: se sei in dubbio, dimentica; non fare domande... rilassati!; essere soli è meglio; fai solo il sesso svelto.
Regole fondamentali
Questa è la dottrina inculcata in modo martellante nei “dormitori”, tragica caricatura di scuola in cui viene insegnato ai (pochissimi) bambini a stare insieme per ignorarsi, attraverso le regole fondamentali della vita: la Cortesia Obbligatoria, lo sviluppo verso l’interiorità, il rispetto della Privacy (sempre maiuscola, come la Cortesia), che si traduce nei divieti di coabitare, di fare domande, di leggere, in quanto anche un contatto puramente intellettuale con il pensiero ed i sentimenti di un altro uomo è considerata inammissibile violazione, penalmente sanzionabile e sanzionata dagli inflessibili robot-ispettori.
Nel cupo mondo che emerge da questi tratti, in realtà la cancellazione della memoria, della storia e dei rapporti non sembra creare felicità. Gli uomini sono “aiutati” a vivere nel rispetto del sistema da due potenti strumenti, droga e televisione, entrambi tassativamente obbligatori. Non ci sono guerre o malattie, ma non esistono neppure lavoro, affetti, arte. E, nonostante nessuno sembri trovare un motivo, o la forza, per ribellarsi, sono sempre più numerosi quanti si “immolano”, dandosi fuoco in luoghi pubblici.
Tre storie
In questo scenario si incrociano tre storie:quella di Bob Spofforth, sofisticatissimo robot, ultima e massima realizzazione della tecnologia, praticamente perfetto e immortale, ma al quale un condizionamento crudele impedisce di realizzare i desideri sommi: “ricordare” l’esistenza dell’uomo il cui cervello è stato usato per programmarlo, e porre fine alla propria esistenza.
Quella di Mary Lou Anne, “disadattata” del perfetto mondo futuro, intollerante alle droghe e insofferente alle regole, miracolosamente sfuggita ai meccanismi di controllo.
E infine quella di Paul Bentley, forse figura autobiografica dell’autore, “educatore” in un dormitorio dell’Ohio, integrato ma con una sotterranea insoddisfazione e che, avendo imparato casualmente a leggere (in un mondo in cui nessuno lo sa più fare), vede aprirsi di fronte a sé una realtà sconosciuta.
Bentley solo alla fine del suo percorso capirà cosa lo ha portato a scontrarsi con tutto ciò cui è stato educato-condizionato: «Quel che avevo desiderato e voluto, anche allora, era essere amato. E amare. E loro non mi avevano nemmeno insegnato la parola».
Un percorso in cui egli è guidato da incontri con persone come Mary Lou, che gli propone un compito del tutto nuovo: “memorizzare la vita”; o con i compagni del carcere, che rappresenteranno la prima esperienza di amicizia, quasi insopportabile per la sua educazione precedente.
E incontri con il genio artistico: Eliot, Bach, Palestrina, che conducono all’ampliarsi «delle mie simpatie verso il mondo, da quello che era il piccolo centro del mio io addestrato in dormitorio».
In fondo, si tratta per Bentley, letteralmente, di riprendere contatto con la realtà, che pure in certi momenti gli pare insopportabile: «Non volevo più vivere con il reale; era troppo gravoso per me».
Ma proprio nei momenti in cui la tentazione di riaffidarsi alla tranquillizzante tutela delle droghe e della televisione si fa più forte, è il ricordo degli incontri fatti a spingere il protagonista a continuare nella sua ricerca, fino all’evasione dal carcere e al viaggio di ritorno verso NewYork e Mary Lou.
Il “doveroso” lieto fine in cui ciascuno sembra trovare ciò che cerca (persino Spofforth nella propria distruzione) poco toglie alla forza di molte pagine del libro.
Un grande assente
Un cenno a parte merita, infine, il ruolo del cristianesimo in Futuro in trance.
Già è presente, e non è poco: uno dei tratti più palesemente inverosimili della produzione fantascientifica è la quasi totale assenza - anche in scenari del futuro prossimo - di qualunque religione storica; le eccezioni, seppur a volte notevoli come nel Cantico per Leibowitz di Miller, sono rarissime, come se pochi decenni di storia potessero cancellare l’esperienza più profonda e radicata dell’uomo.
Anche in questo Tevis si dimostra perlomeno realista; d’altra parte, come potrebbe uno come Bentley, che inizia a divorare libri di ogni genere (compresi i dizionari) non trovarsi di fronte al Libro per eccellenza, la Bibbia?
Ma per il protagonista l’incontro con la religione è segnato da una profonda contraddizione. Leggendo il Nuovo Testamento, Bentley riconosce che «se qualcuno venisse da me e mi dicesse “Io sono la via, la verità, la vita” vorrei credergli con tutte le mie forze. È quello che cerco: la verità, la vita».
Ciò che non gli viene offerto è, forse, la via: la setta religiosa di stampo veterotestamentario incontrata da Bentley nel suo pellegrinaggio è una ben misera caricatura del cristianesimo, in cui egli non riconosce - e forse non può riconoscere - una risposta alla domanda di senso che lo tormenta.
Drammaticamente, il giudizio che egli dà sulla comunità, allontanandosene, è forse un giudizio anche sulla propria traiettoria umana: «Credo ora che si aspettassero una specie di miracolo quando cominciarono a sentire le parole della Bibbia lette ad alta voce… ma non vi è stato alcun miracolo, e presto hanno perso ogni interesse reale».
Il miracolo di Dio fatto uomo, ciò che Bentley non trova sul suo cammino, e a cui pure vorrebbe credere con tutte le sue forze.
Questo “incontro mancato”, in un mondo per tanti versi e non casualmente simile al nostro, costituisce una domanda bruciante per ciascuno di noi.
Vita...
Nato il 28 febbraio 1928 a San Francisco, professore di letteratura inglese all’università dell’Ohio.
Studia all’Università del Kentucky e dello Iowa, laureandosi in lingua inglese.
Presta servizio militare nella Marina degli Stati Uniti.
Nel ‘59 scrive la sceneggiatura per Lo spaccone, diretto da Robert Rossen.
Esordisce nel ‘57, col racconto The lfth of Oofth.
È morto il 9 agosto 1984.
...bibliografia
Romanzi
L’uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth, 1963), “Oscar fantascienza” n. 88, Mondadori, 1990
Futuro in trance (Mockingbird, 1980), “Classici Urania” n. 240, Mondadori, 1997
A pochi passi dal sole (The steps on the sun, 1983), “Urania” n. 1183, Mondadori, 1992
The Hustler (1959) e The Color of Money (1984) da cui furono tratti rispettivamente i film Lo spaccone (di R.Rossen) e Il colore dei soldi (di M. Scorsese) entrambi interpretati da Paul Newman.
Antologie
Lontano da casa (Far From Home, 1981) “Urania” n. 1162, Mondadori 1991.
