Il caso Lomax 2 - Tra sevizie e ritorno in patria
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
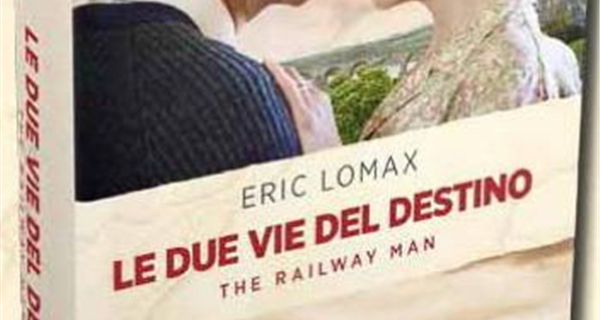
Tra sevizie e ritorno in patria
Eric Lomax (Edimburgo, 30 maggio 1919 - Berwick-upon-Tweed, 8 ottobre 2012) si arruolò nell’esercito britannico nel 1939 e fu inviato con il grado di tenente nel sud-est asiatico come addetto alle comunicazioni radio. La sua infanzia e la giovinezza erano state caratterizzate dalla fortissima passione per le ferrovie e le locomotive a vapore: un mix di fascinazione, curiosità e ossequio al prodotto più avanzato della rivoluzione industriale inglese. Interrotti gli studi liceali, si impiegò come telegrafista alle Poste e di lì a poco si arruolò.
Nel 1942, dopo la resa di Singapore, fu catturato e subì, insieme ai suoi compagni, maltrattamenti e torture: la kempeitai, la polizia militare giapponese paragonabile alla Gestapo nazista, pretendeva di trovare le prove di un presunto complotto ordito dai prigionieri britannici. Nel suo caso, un ulteriore elemento complicava le cose, peggiorando la sua situazione: i giapponesi volevano sapere perché avesse tracciato su un foglio una mappa della ferrovia. Era impossibile convincerli, come tentò di fare, che era “un patito delle ferrovie”! Mentre veniva bastonato ripetutamente, Lomax notò il comportamento singolare dell’interprete giapponese: “Credo di aver sentito la sua mano sulla mia: un gesto insolito, il contrasto osceno tra un atto quasi amichevole e la spietata violenza che mi stava infliggendo.” Ciò spiega come mai fin da allora, e negli anni seguenti, la figura di quell’interprete fece da catalizzatore di tutta la carica di odio di Lomax per i suoi aguzzini: “Era l’interprete che avrei voluto uccidere!”
Dopo le torture, Lomax fu condannato alla prigionia nel carcere-lager di Outram Road, dove il regime era altrettanto inumano: di giorno i prigionieri dovevano sedere immobili per ore, in silenzio a gambe incrociate, e la notte dormire con la luce accesa. Con grande abilità, riuscì a farsi ricoverare in ospedale per ben due volte, sentendo di non reggere oltre.
Un secondo momento assai critico e altrettanto decisivo fu il ritorno in patria dopo la fine della guerra. Al pari di molti altri reduci, egli non sopportò il rientro nella “normalità”, specialmente se questa significava la ripresa dei rapporti con persone che, non avendo vissuto le sue terribili esperienze, non potevano immaginare di che cosa si trattasse, né volevano saperlo. Lomax trovò che molti dei suoi concittadini fossero prigionieri della propria meschinità senza esserne consapevoli.
Tre settimane dopo il suo arrivo, sposò la giovane con cui si era fidanzato prima di arruolarsi: “Eravamo quasi degli sconosciuti, mi lasciai persuadere dalla mia docilità, dal suo entusiasmo e dall’immagine romantica che avevo conservato di lei nella buona e nella cattiva sorte. Ero innamorato, certo, ma di che cosa? (…) Vivevo già in un mondo separato; la riservatezza di chi ha subìto la tortura è più impenetrabile di una fortezza su un’isola.” La loro unione entrò presto in crisi: “Non dev’essere stato facile per lei. Una delle prime cose che fu costretta a fare fu spalmare un unguento speciale sulla mia pelle infetta; la tigna e gli eczemi furono il mio contributo alla luna di miele (…) I suoi sogni romantici andarono a infrangersi contro un giovane nervoso, pallido e debilitato. Fu una vittima della guerra come me”. Le pagine dedicate alla prima moglie e ai tre figli, uno dei quali morì quando aveva appena un anno, sono delicate e toccanti.
Decise di espatriare. Fece in modo di essere assegnato dal Ministero delle Colonie alla Costa d’Oro (l’attuale Ghana), dove si stabilì con la famiglia. In qualità di funzionario coloniale britannico (uno degli ultimi, per via della decolonizzazione), svolse anche funzioni da magistrato: “nei casi di affidamento dei minori, per esempio, lasciavo che fossero i bambini a decidere con chi volessero stare.” In un certo senso, fu un antesignano della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo (1996).
Rientrato in patria nel 1955, lavorò per la Società Scozzese del Gas, quindi insegnò gestione del personale all’Università di Strathclyde fino al pensionamento, nel 1982. Poco tempo prima, la distanza dalla moglie si era fatta incolmabile, ed egli se ne allontanò a poco a poco e per sempre.
Nel 1980 conobbe in treno Patricia Wallace (Patti), più giovane di lui di 17 anni, un’infermiera vissuta molti anni in Canada; anch’essa aveva alle spalle un matrimonio in crisi. (9) Patti aveva tre figli maschi, che portò con sé quando sposò Lomax, il quale annota: “In un momento in cui qualunque svolta emotiva sembrava impossibile e non facevo altro che pregustare la mia vendetta, mi ero innamorato.”
Nonostante il profondo affetto e la stima sincera per Patti, egli non le raccontò nulla degli anni di prigionia. Non solo: la loro intesa era disturbata da certe sue reazioni sproporzionate, come quella volta in cui egli girava per casa mezzo nudo dopo il pisolino pomeridiano, la moglie lo vide avvicinarsi e per tutta risposta gli lanciò uno strofinaccio all’altezza dei genitali; al che lui rimase impietrito e fortemente irritato da quel gesto, incapace di coglierne il senso scherzoso. È solo un esempio di quel conflitto intrapsichico che, per usare le parole di Freud, “si svolge tra il vecchio Io pacifico e il nuovo Io bellicoso del soldato”, una specie di stato confusionale in cui non si distingue più tra offesa e difesa. (10)
Lomax racconta in modo dettagliato i disturbi di cui soffrì per molti anni, tra cui gli incubi: “Facevo qualcosa di assolutamente innocente e all’improvviso mi ritrovavo a Outram Road, vittima di una giustizia arbitraria, sapendo che non mi avrebbero mai rilasciato perché non vi era ragione alcuna per avermi arrestato.” Questo frammento mostra bene la presenza di categorie logiche e giuridiche nel lavoro onirico: una pena sanziona sempre un illecito ? qui non ve ne erano stati ? la pena è illegittima e illogica ? dunque non finirà mai.
Confesso che l’idea di giungere ad una interpretazione psicoanalitica dei sintomi, incubi e sogni di Lomax mi ha sfiorato, ma me ne sono in parte astenuto. In parte, perché la ricapitolazione del suo resoconto sotto il concetto di appuntamento è, ad ogni buon conto, un’interpretazione. Per proseguire si dovrebbe poter disporre di altri documenti e fonti.
Il superamento dell’odio
Dopo il pensionamento, Lomax non poté più “rimandare il bisogno di sapere, il desiderio si fece più intenso che mai”. Nel 1985 scrisse un articolo su un bollettino per ex-prigionieri di guerra, cercando testimoni oculari di quanto era accaduto nel suo campo di prigionia e ricevendo diverse lettere di risposta. Scrisse anche a Helen Bamber, direttrice della Fondazione Medica per la Cura delle Vittime della Tortura, che aveva sede a Londra. (11) Dal 1987 al 1989 “Patti ed io frequentammo questo luogo straordinario ogni quattro settimane, facendo ogni volta un viaggio di 600 miglia.” Lomax rimase molto sorpreso che qualcuno lo stesse a sentire e fosse all’altezza di capire che razza di inferno aveva attraversato. La Bamber si rivelò una donna straordinaria: “Ricevetti da Helen l’invito a diventare il primo ex-soldato della seconda guerra mondiale a essere accettato come paziente della Fondazione. Questo fatto mi cambiò la vita, a quasi settant’anni di età.” Come a dire: il pensiero non va mai in pensione.
Lomax cercava la ragione di quanto gli era accaduto, voleva capire come mai i giapponesi fossero piombati nella sua tenda e avessero scoperto la radio da campo che egli aveva costruito. Il dubbio che qualcuno l’avesse tradito emerge molto chiaramente dal testo, e non senza ragione, perché tutto quel che poi aveva subìto non era stato l’effetto di uno tsunami o di altro disastro naturale, ma il prodotto di atti umani: rintracciare qualcuno cui poter imputare quel che aveva sofferto diventava sempre più importante.
Nel 1989 si imbatté in un articolo del Japan Times che menzionava un certo Takashi Nagase, un interprete che aveva aiutato gli alleati a ritrovare i cadaveri dei prigionieri morti (a migliaia) lungo la ferrovia. Si trattava certo dello stesso interprete della kempeitai che aveva presenziato al suo “interrogatorio”. E poiché costui era stato l’unico degli aguzzini che parlasse inglese, Lomax gli si era rivolto con una speciale e disperata fiducia, arrivando a vedere in lui “una sorta di odiato confidente”.
Dopo il 1945, Nagase aveva fatto costruire a proprie spese un tempio buddhista dedicato alle vittime della guerra. Lomax sentì il bisogno crescente di verificare se i rimorsi di quell’uomo fossero genuini: “stava prendendo forma, dapprima vagamente, l’idea di incontrarlo, di decidere guardandolo dritto in faccia.” Gli dissero che il suo proposito non aveva precedenti. Persino “Helen Bamber non ricordava, nella storia dell’Europa post-bellica, un solo caso in cui una vittima avesse volontariamente incontrato un complice dei suoi aguzzini.”
Nagase aveva pubblicato un libretto, Crosses and Tigers (Croci e tigri), poi tradotto in inglese. Lomax se lo procurò, lo lesse, scoprì che il giapponese aveva narrato anche il suo interrogatorio nonché la propria pena per quel giovane ufficiale inglese torturato.
Non solo: Nagase, recatosi in Thailandia quasi vent’anni dopo la guerra, mentre si accingeva a pregare nella quiete di un cimitero di guerra, aveva avuto la sensazione di essere stato in qualche modo perdonato. Leggendo quelle righe, Patti andò su tutte le furie e chiese al marito il permesso di scrivere a quell’uomo. E così fece: “Come può credere di essere ‘perdonato’, signor Nagase, se questo ex-prigioniero di guerra non l’ha ancora perdonata?”
Fu l’inizio di una corrispondenza straordinaria, poiché Nagase rivelò subito di essere tormentato dai rimorsi da molti anni. L’idea di un incontro si fece sempre più strada. I Lomax cercarono e trovarono i finanziamenti necessari per il viaggio, rivolgendosi ad una Fondazione franco-giapponese e concordando persino a chi dovessero andare i diritti del documentario che sarebbe stato girato sull’incontro con Nagase. (12)
In quel periodo, qualcuno suggerì a Lomax “che forse era tempo di perdonare e di dimenticare”. Ma egli annota: “la maggior parte di coloro che consigliano di perdonare non ha idea di quello che ho passato. Non ero pronto a perdonare, non ancora, probabilmente non lo sarei mai stato.”
NOTE
9. Segnalo l’intervista Pride and Pain of Patti Lomax, the Railway Man’s Wife, https://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/10563733/Pride-and-pain-of-Patti-Lomax-the-Railway-Mans-wife.html
10. S. Freud, Introduzione al libro “Psicoanalisi delle nevrosi di guerra” (1919), OSF, vol. IX, pagg. 67-75. Freud tornò sullo stesso tema anche l’anno seguente con un breve e interessantissimo scritto di carattere peritale: Promemoria sul trattamento elettrico dei nevrotici di guerra (1920), OSF, vol. IX, pagg. 169-175.
11. Helen Bamber (1925-2014), nata a Londra da una famiglia di esiliati polacchi di origine ebraica, trascorse, appena ventenne, più di due anni a Bergen-Belsen, soccorrendo i sopravvissuti di quel lager e aiutandoli a trovare un luogo dove andare e un motivo per vivere. In seguito, ella dedicò tutta la vita ad aiutare vittime di maltrattamenti di ogni genere, ottenendo un gran numero di riconoscimenti. Per un approfondimento sulla figura di Helen Bamber, si veda: http://www.unive.it/media/allegato/dep/n33/15_Donne_umanitarie.pdf
12. Il documentario dal titolo Enemy, My Friend? uscì nel 1995 con la regia di Mike Finlason. Sul web se ne può vedere un breve e commovente brano: https://www.youtube.com/watch?v=do3FwIymiqI. Il lettore che è arrivato sin qui dovrebbe dedicarvi un momento. Vi è anche un’intervista rilasciata da Patti Lomax e da Finlason: https://www.youtube.com/watch?v=jDhZDaS2zNA, e alcune foto dell’evento:
http://www.therealrailwayman.com/railwayman-gallery.html.
