Il calendario del 22 Febbraio
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
- Email:
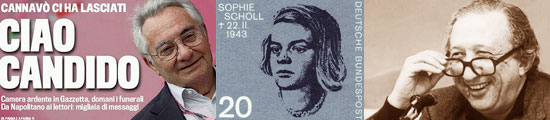
Eventi
▪ 1495 - Re Carlo VIII di Francia entra a Napoli reclamandone il dominio.
▪ 1847 - Guerra messicano-statunitense: nella battaglia di Buena Vista 5.000 soldati statunitensi sconfiggono 15.000 messicani.
▪ 1848 - In Francia scoppia la rivoluzione contro re Luigi Filippo che darà vita alla Seconda Repubblica francese.
▪ 1862 - Jefferson Davis e Alexander Stephens si insediano ufficialmente quali presidente e vicepresidente degli Stati Confederati d'America.
▪ 1931 - Viene varata la Amerigo Vespucci, tuttora in servizio, ed utilizzata per l'addestramento degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno.
▪ 1943 - I membri della Rosa Bianca vengono "processati" e giustiziati dai nazisti.
▪ 1979 - L'isola di Saint Lucia ottiene l'indipendenza dal Regno Unito.
▪ 1980
- - Roma, Valerio Verbano, studente di 18 anni vicino agli ambienti dell'Autonomia Operaia, viene ucciso con un colpo alla nuca da tre neofascisti che lo attendono a casa sua, dopo esservisi introdotti e aver immobilizzato i genitori
- - La nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell'Unione Sovietica alle Olimpiadi di Lake Placid, nell'incontro noto come Miracolo sul ghiaccio.
▪ 1994 - Aldrich Ames e sua moglie vengono accusati dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti di aver spiato per l'Unione Sovietica.
▪ 1997 - A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la pecora Dolly.
* 2002 - Viene ucciso da militari governativi Jonas Malheiro Savimbi leader dell'UNITA.
Anniversari
▪ 1297 - Margherita da Cortona (Laviano, Perugia, 1247 – Cortona, 22 febbraio 1297) è stata una religiosa italiana del Terz'Ordine Francescano. Nel 1728 è stata proclamata santa da papa Benedetto XIII.
Di umili origini, venne battezzata presso una pieve di Pozzuolo Umbro, dove attualmente sorge la chiesa dei Santi Pietro e Paolo: rimase presto orfana di madre e dall'età di diciassette anni visse come concubina con un nobile di Montepulciano, Arsenio del Pecora dei signori di Valiano, dal quale ebbe anche un figlio.
Nel 1273 Arsenio, mentre visitava una delle sue proprietà di Petrignano del Lago, venne aggredito e assassinato da un gruppo di briganti. Secondo la tradizione, il suo fedele cane condusse Margherita al suo cadavere sfigurato.
Scacciata col figlio dai famigliari dell'amante, rifiutata dal padre e dalla sua nuova moglie, si pentì della sua vita e si convertì. Si avvicinò ai francescani di Cortona, in particolare ai frati Giovanni da Castiglione e Giunta Bevegnati, suoi direttori spirituali e poi biografi: affidò la cura del figlio ai frati minori di Arezzo e nel 1277 entrò nel Terz'Ordine di San Francesco, dedicandosi esclusivamente alla preghiera ed alle opere di carità. La sua spiritualità pone attenzione particolare alla Passione di Cristo, in linea con quanto vissero Francesco d'Assisi, Angela da Foligno e più tardi Camilla da Varano, ossia la clarissa sr. Battista.
Diede vita ad una congregazione di terziarie, dette le Poverelle; fondò nel 1278 un ospedale presso la chiesa di San Basilio e formò la Confraternita di Santa Maria della Misericordia, per le dame che intendevano assistere i poveri ed i malati.
Onorata come beata sin dalla morte, Innocenzo X ne approvò il culto il 17 marzo 1653, ma fu canonizzata soltanto il 16 maggio 1728 da Benedetto XIII.
Il Martirologio Romano fissa per la sua memoria liturgica la data del 22 febbraio.
La biografia redatta dal suo confessore frà Giunta Bevegnati (in AA. SS., mense Februarii, die 22), con i racconti delle numerose estasi e visioni di Margherita, ha contribuito a renderla una delle sante più popolari dell'italia centrale.
Il suo corpo è conservato a Cortona, nella basilica a lei intitolata, in un'urna collocata sopra l'altare maggiore, bordata da una cornice in lamina d'argento sbalzata e cesellata e pasta vitrea
Presso la frazione di Petrignano del Lago, nel luogo della tragedia e decisione di conversione (il cosiddetto Pentimento) vi è una pieve ed una quercia tuttora in vita ai cui piedi ella pregò, considerata sacra ed intangibile. Nell'estate 1972, per il settimo centenario dell'evento ci sono state grandi celebrazioni nel Castiglionese con ostensione delle sue spoglie.
Nell'arte, è spesso raffigurata col saio francescano ed il velo bianco, in compagnia di un angelo consolatore (Traversi) o in estasi davanti al Cristo (Lanfranco): è sempre accompagnata dal cane che le fece scoprire il cadavere dell'amante (Benefial).
▪ 1512 - Amerigo Vespucci (Firenze, 9 marzo 1454 – Siviglia, 22 febbraio 1512) è stato un navigatore ed esploratore italiano.
Fu tra i primi e più importanti esploratori del Nuovo Mondo, tanto da lasciare il suo nome al continente.
La sua vita
Terzo figlio di Anastasio o Nastagio Vespucci, notaio fiorentino, e di Elisabetta o Lisa Mini, nobildonna di Montevarchi, nel 1489 si trasferì a Siviglia su incarico del banchiere Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici. A Siviglia conobbe Cristoforo Colombo. Fu uno dei cinque principali navigatori italiani dell'epoca delle grandi scoperte geografiche.
Nel 1499 si unì ad Alonso de Hojeda, il quale aveva ricevuto dalla Spagna l'incarico di esplorare, in direzione sud, le coste del continente scoperto da Colombo.
Navigatore e profondo studioso dei mari, durante i suoi viaggi esplorò gran parte delle coste orientali del Sud America. Fu tra i primi sostenitori dell'idea che avesse scoperto un nuovo continente e non una rotta occidentale per raggiungere l'Estremo Oriente per mare.
La figura di Amerigo Vespucci è molto controversa, a causa delle sue lettere la cui autenticità è stata spesso messa in discussione: la Mundus Novus ("Nuovo Mondo") e la Lettera (o "Il quarto viaggio").
Alcuni sostengono che Vespucci abbia esagerato il suo ruolo e romanzato gli avvenimenti, altri che abbia contraffatto gli originali di altri viaggiatori dell'epoca.
Le due lettere contestate parlano di quattro viaggi in America. Attualmente vi è una disputa tra alcuni illustri storici (Germán Arciniegas e Gabriel Camargo Perez) che sostengono che il primo viaggio di Vespucci sia avvenuto insieme a Juan de la Cosa nel giugno del 1497, con probabile comandante Juan Díaz de Solís, e altri che ritengono che questo viaggio non sia mai avvenuto.
In ogni caso nelle sue lettere Amerigo Vespucci descrisse la terraferma visitata come un "Nuovo Mondo" e fu il primo a rendersi conto di essere al cospetto di un nuovo continente. Il fatto che sia stato o no il primo europeo a giungere nella terraferma americana per primo (il 24 giugno 1497), curiosamente lo stesso giorno che Giovanni Caboto pose piede nell'isola di Cab Breton, nel territorio di Nuova Scozia, non ha particolare importanza. Quello che importa è che nelle sue lettere, indirizzate a Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, descrive con dovizia di particolari i nuovi territori, i popoli visitati, la fauna e si rende conto che quel nuovo continente non può essere l'Asia.
Fu la rapida diffusione delle lettere circolate a suo nome che indusse il cartografo Martin Waldseemüller a usare il genere femminile (America) del suo nome latinizzato (Americus Vespucius), per indicare il nuovo continente in una carta del mondo disegnata nel 1507, contenuta nella Cosmographiae Introductio.
L'idea di Waldseemüller era che l'appellativo si riferisse all'attuale America meridionale, cioè alle terre toccate da Vespucci.
Qui di seguito si riporta un passo di una delle lettere, nel quale Vespucci si rende conto di essere al cospetto "della quarta parte della Terra" e cioè di un nuovo continente:
«Arrivai alla terra degli Antipodi, e riconobbi di essere al cospetto della quarta parte della Terra. Scoprii il continente abitato da una moltitudine di popoli e animali, più della nostra Europa, dell'Asia o della stessa Africa»
Amerigo Vespucci fu nominato, nel 1508, "Piloto Mayor de Castilla", dal re Ferdinando II di Aragona. Questo titolo era importante perché era il responsabile di organizzare le spedizioni nelle nuove terre e di formare piloti e cartografi, insegnando loro l'uso del quadrante e dell'astrolabio.
Vespucci morì nel 1512 a Siviglia, in Andalusia. Non ebbe discendenza, ma lasciò i suoi beni alla moglie, l'andalusa Maria Cerezo. Fu Terziario Francescano
▪ 1687 - Francesco Lana de Terzi (Brescia, 13 dicembre 1631 – Brescia, 22 febbraio 1687) è stato un gesuita, matematico e naturalista italiano.
Nato dalla nobile famiglia Terzi, originaria della vicina Franciacorta, dopo aver frequentato il Collegio dei Nobili di Sant'Antonio, l'11 novembre 1647 entra nella Compagnia di Gesù.
Unisce lo studio e la ricerca in svariati campi dello scibile umano a viaggi, che lo portano a visitare molte città d'Italia. A Terni insegna grammatica e retorica, scrivendo nel frattempo una piccola opera dedicata al protettore della città. Insegna poi matematica e fisica a Ferrara, finché la sua salute cagionevole lo costringe a ritornare a Brescia, dove diviene insegnante di filosofia nel convento di Santa Maria delle Grazie. Intraprende lunghi viaggi verso i territori vicini, i laghi di Garda, Iseo e Idro, e le valli, Camonica, Sabbia e Trompia, traendo dalle sue esplorazioni il trattato Storia naturale Bresciana, che rimarrà in forma di manoscritto.
L'aeronave
Francesco Lana de Terzi propone il primo serio tentativo di realizzare un velivolo volante più leggero dell'aria. Nel 1670 pubblica infatti il libro Prodomo, che contiene un capitolo intitolato Saggio di alcune invenzioni nuove premesso all'arte maestra nel quale è riportata la descrizione di una nave volante, un vascello più leggero dell'aria da lui immaginato nel 1663 sviluppando un'idea suggerita dagli esperimenti di Otto von Guericke con gli emisferi di Magdeburgo.
Secondo il progetto, che intendeva "fabricare una nave, che camini sostenata sopra l'aria a remi, & a veli", il velivolo doveva essere sollevato per mezzo di quattro sfere di rame, dalle quali doveva essere estratta tutta l'aria. La chiglia sarebbe stata appesa alle sfere di rame (di circa 7,5 metri di diametro), con un albero a cui era attaccata una vela; secondo i suoi calcoli, quando nelle sfere veniva fatto il vuoto, esse divenivano più leggere dell'aria e offrivano una spinta ascensionale sufficiente a sollevare la barca e sei passeggeri.
Oggi sappiamo che la realizzazione del progetto non è fisicamente possibile, perché la pressione dell'aria farebbe implodere le sfere e perché sfere sufficientemente resistenti avrebbero un peso superiore alla spinta fornita. Ma il grande merito dello scienziato è di aver per primo applicato alla navigazione aerea il principio di Archimede, lo stesso che consente alle navi di galleggiare sull'acqua e che nel 1783 porterà all'aerostato dei fratelli Montgolfier.
Notevole anche il progetto del Magisterium naturæ et artis, opera enciclopedica in nove volumi, di cui però solo i primi due furono completati.
▪ 1913 - Ferdinand de Saussure (Ginevra, 26 novembre 1857 – Vufflens-le-Château, 22 febbraio 1913) è stato un linguista svizzero. È considerato il fondatore della linguistica moderna, in particolare di quella branca conosciuta con il nome di strutturalismo.
Nacque a Ginevra nel 1857, da une famiglia illustre: nipote del chimico e botanico Nicolas-Théodore e pronipote del naturalista, geologo e fondatore dell'alpinismo Horace-Bénédict, Ferdinand era figlio dell entomologista Henri de Saussure e di Louise de Pourtalès, fratello quindi del sinologo Léopold de Saussure e dell'esperantista René de Saussure. A sua volta, Ferdinand sarebbe divenuto padre del medico e psicanalista Raymond de Saussure.
Mostrò fin dall'infanzia un'intelligenza viva e precoce, soprattutto in ambito linguistico. Compì i suoi studi nella città natale e quindi nelle Università di Lipsia e Berlino.
Insegnò dal 1881 al 1901 presso l'Università di Parigi, dove collaborò con Michel Bréal, Louis Havet e James Darmesteter ed ebbe come allievi, tra gli altri, Antoine Meillet, Paul Passy e Maurice Grammont. Nel 1901, per ragioni famigliari, tornò nella città natale; all'Università di Ginevra tenne le cattedre di lingue indoeuropee e di sanscrito e, dal 1906, quella di linguistica generale, creata ad hoc; tra i suoi allievi, Albert Sechehaye e Charles Bally, fondatori della Scuola di Ginevra, e il russo Sergej Karcevskij.
Nel 1912, ammalatosi di tumore, si ritirò nella residenza di famiglia di Vufflens-le-Château, ove morì l'anno seguente. Dalla moglie Marie Faesch (1867-1950) aveva avuto tre figli: Jacques, Raymond e André.
▪ 1943 - Sophie Scholl (Forchtenberg, 9 maggio 1921 – Monaco di Baviera, 22 febbraio 1943) è stata una studentessa e antifascista tedesca, attivista del gruppo antinazista della "Rosa Bianca" ed emblema della ribellione non violenta al Reich.
Sophie nacque, quarta di cinque figli, il 9 maggio 1921 a Forchtenberg; suo padre era il sindaco del paese. Nel 1930 la sua famiglia si trasferì a Ludwigsburg e due anni dopo a Ulma dove si stabilì definitivamente. A dodici anni fu obbligatoriamente iscritta alla gioventù hitleriana.
Legata da un affetto speciale al fratello maggiore Hans la giovane Sophie ebbe il primo drammatico impatto con la crudeltà del regime nel 1937, quando l'arresto di Hans da parte dei nazisti la toccò nel profondo.
Nel 1940 Sophie trovò lavoro come maestra d'asilo a Ulm-Söflingen e venne poi costretta a servire come ausiliaria per sei mesi in un istituto statale di Blumberg. Nel 1942 poté iscriversi all'Università di Monaco, dove studiava anche suo fratello Hans. Nello stesso anno suo padre venne arrestato e condannato ad un breve periodo di detenzione per aver criticato pubblicamente la politica di Adolf Hitler.
Sempre nell'estate del 1942 Sophie decise di aderire alla "Rosa Bianca" e come tale si occupò della preparazione dei volantini e della loro distribuzione.
L'arresto
Il 18 febbraio 1943, mentre piazzava dei volantini all'Università di Monaco, Sophie fu arrestata insieme al fratello. Sottoposta per 4 giorni a interrogatorio da parte della Gestapo, fu riconosciuta colpevole di tradimento e processata insieme al fratello Hans e all'amico Christoph Probst, nel frattempo arrestato anche lui.
L'uomo della Gestapo che la interrogava le chiese: « "... non si sente colpevole di aver diffuso e aiutato la Resistenza, mentre i nostri soldati combattevano a Stalingrado? Non prova dispiacere per questo?", e lei rispose:"
No, al contrario! Credo di aver fatto la miglior cosa per il mio popolo e per tutti gli uomini. Non mi pento di nulla e mi assumo la pena!"»
Proprio nel momento della condanna Sophie è più decisa che mai a mandare avanti la Rosa Bianca.
Il 22 febbraio 1943 i tre ragazzi furono condannati a morte dal "Tribunale del Popolo" presieduto dal giudice Roland Freisler e ghigliottinati lo stesso giorno nel cortile della prigione di Monaco Stadelheim.
* 1944 - Kastürbā Gāndhi, soprannominata Ba (11 aprile 1869 – 22 febbraio 1944), è stata una pacifista indiana, moglie di Mahatma Gandhi. Figlia del ricco uomo d'affari Gokuladas Makharji, di Porbandar, Kasturba sposò Mohandas Karmchand Gandhi in un matrimonio combinato, quando entrambi avevano 13 anni.
All'epoca era analfabeta e Gandhi le insegnò a scrivere e a leggere, il che si sarebbe rivelato molto importante, considerato il livello di alfabetizzazione delle donne indiane dell'epoca considerata. Quando suo marito nel 1888 partì per Londra per motivi di studio, Kasturba rimase in patria per crescere Harilal, il primo figlio della coppia. Ebbero altri tre figli: Manilal (1892), Ramdas (1897), e Devdas (1900).
Nel 1906, Mohandas Gandhi decise di praticare il Brahmacharya, praticando il celibato. Sebbene ella sia rimasta al fianco di suo marito, non accettò sempre con facilità le sue idee. Gandhi dovette lavorare molto per convincerla ad accettare il suo punto di vista. Kasturba era molto religiosa e, come suo marito, rinunciò alle divisioni in caste e viveva in ashram.
Spesso Kasturba si unì a suo marito nell'attivismo politico. Si recò in Sudafrica nel 1897 insieme a Mohandas. Dal 1904 al 1914 fu attiva nell'insediamento di Phoenix, vicino Durban. Durante le proteste del 1913 contro le condizioni di lavoro degli indiani in Sudafrica, Kasturba fu arrestata e condannata a tre mesi di lavori forzati. In seguito, in India, quando suo marito veniva arrestato era lei, a volte, a prendere il suo posto. Nel 1915, quando Gandhi tornò in India per sostenere la lotta dei piantatori indigeni, Kasturba lo accompagnò, e insegnò l'igiene, la disciplina, la lettura e la scrittura a donne e bambini.
Kasturba soffriva di bronchite cronica. Gli arresti e la repressione contro il Quit India Movement e la vita in ashram peggiorarono le sue condizioni. Contrasse la polmonite mentre il marito era in carcere, e questi rifiutò di farle somministrare la penicillina. Morì di infarto il 22 febbraio 1944.
▪ 1987 - Andy Warhol, nome d'arte di Andrew Warhola (Pittsburgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 febbraio 1987), è stato un pittore, scultore e regista statunitense, figura predominante del movimento pop art americano.
Figlio di immigrati ruteni del villaggio di Miková presso Medzilaborce, mostrò subito il suo talento artistico, e studiò arte pubblicitaria al Carnegie Institute of Technology (CIT), ora conosciuto come Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Dopo la laurea, ottenuta nel 1949, si trasferì a New York. La grande mela gli offrì subito molteplici possibilità di affermarsi nel mondo della pubblicità, lavorando per riviste come Vogue e Glamour. Warhol apparteneva devotamente alla Chiesa greco-cattolica rutena.
Morì a New York il 22 febbraio 1987, alle 5.45 del mattino, in seguito a un intervento chirurgico alla cistifellea, dopo aver realizzato Last Supper, ispirato all’Ultima cena di Leonardo, che fu esposto a Milano. I funerali si svolsero a Pittsburgh, sua città natale, e a New York venne celebrata una messa commemorativa.
Pittura
La sua attività artistica conta tantissime opere, produceva in serie le sue opere con l'ausilio dell'impianto serigrafico. Le sue opere più famose sono diventate delle icone: Marilyn Monroe, Mao Zedong, Che Guevara e tante altre. La ripetizione era il suo metodo di successo: su grosse tele riproduceva moltissime volte la stessa immagine alterandone i colori (prevalentemente vivaci e forti). Prendendo immagini pubblicitarie di grandi marchi commerciali (famose le sue bottiglie di Coca Cola, le lattine di zuppa Campbell's, e i detersivi Brillo) o immagini d'impatto come incidenti stradali o sedie elettriche, riusciva a svuotare di ogni significato le immagini che rappresentava proprio con la ripetizione dell'immagine su vasta scala.
La sua arte, che portava gli scaffali di un supermercato all'interno di un museo o di una mostra d'arte, era una provocazione nemmeno troppo velata: secondo uno dei più grandi esponenti della Pop Art l'arte doveva essere consumata come un qualsiasi altro prodotto commerciale.
Ha spesso ribadito che i prodotti di massa rappresentano la democrazia sociale e come tali devono essere riconosciuti: anche il più povero può bere la stessa Coca Cola che beve Jimmy Carter o Liz Taylor. Fra i suoi assistenti, che successivamente divennero essi stessi famosi, figurò Ronnie Cutrone.
Successivamente rivisitò anche le grandi opere del passato, come L'ultima cena di Leonardo da Vinci o capolavori di Paolo Uccello e Piero della Francesca: anche in questo caso cercò di rendere omaggio a delle opere d'arte al posto dei mass media che in alcuni casi cercarono di screditarlo,tuttavia la pop art fu una delle icone principali che accompagnarono il boom economico.
Scultura
Andy Warhol ha anche creato alcune sculture che riproponevano in tre dimensioni alcuni suoi lavori serigrafici più famosi, come ad esempio scatole di detersivo Brillo ed altri prodotti in scatola.
È stato anche fondatore della Factory, luogo in cui giovani artisti newyorkesi potevano trovare uno spazio collettivo per creare: qui sono nati o passati per un breve periodo altri famosi artisti come Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring.
Il 3 giugno 1968, un'artista frequentatrice della Factory, Valerie Solanas, sparò ad Andy Warhol e al suo compagno di allora Mario Amaya. Entrambi sopravvissero all'accaduto, anche se Andy Warhol in particolare riportò gravi ferite e si salvò in extremis. Valerie Solanas dichiarò di aver sparato perché Warhol aveva troppo controllo sulla sua vita: successivamente scrisse anche una sceneggiatura dell'accaduto proponendola addirittura allo stesso Warhol, che rifiutò categoricamente. Le apparizioni pubbliche di Warhol dopo questa vicenda diminuirono drasticamente.
Il 23 luglio 1985 fa da testimonial al lancio del nuovo computer della Commodore: l'Amiga 1000. Sempre negli anni ottanta è testimonial della rivista Vogue America.
L'interesse di Warhol per il cinema si manifesta a partire dal 1963, quando l'artista, dopo aver frequentato la cinémathèque di Jonas Mekas, decide di comperarsi una cinepresa Bolex 16mm. I film di Warhol di questo primo periodo si possono definire 'minimali': Sleep, Kiss, Eat, Empire, tutti del 1963-1964, mostrano azioni ripetute dilatate nel tempo, riprese con una camera fissa. A Warhol interessa la composizione dell'immagine che si viene a creare partendo da un unico punto di vista. Questi primi film sono come quadri che, invece di essere appesi, sono proiettati su una parete bianca.
I film sperimentali senza sonoro sono girati in 16mm alla velocità di 24 fotogrammi per secondo e proiettati alla velocità di 16 fotogrammi al secondo; questa caratteristica 'rallenta' e amplifica l'immagine del film, che viene percepito in un tempo lunghissimo. Luogo fondamentale sia per la sperimentazione che per l'ispirazione nel mondo del cinema di Warhol è la Silver Factory, l'ampio locale ubicato al quarto piano di un ex fabbrica di cappelli sulla 47° strada, è stato il più noto studio laboratorio di Warhol, teatro di molti progetti artistici tra il 1963 e il 1968. Circondato da persone cui chiede suggerimenti ed idee, Warhol lavora alla Factory con ritmi di "catena di montaggio". La Factory è una "open house", un luogo aperto in cui tutti possono partecipare, anzi, sono invitati a farlo, perché è dalle idee e dalla personalità di ognuno che Warhol trae il materiale per la sua arte.
Nello studio gravitava un mondo di originali "intorno ad una figura che si faceva chiamare 'capo', ma che era orgoglioso di non dare mai l'impressione di avere la minima individualità, di non essere mai altro che lo specchio del suo entourage, la copia di ciò che i suoi cortigiani volevano che fosse".
La Factory diventa così uno spazio ideologico dove molte nozioni sulla pop art si trasformano in stile di vita. Il gruppo forma un nucleo che stabilisce un linguaggio comune, uno stile comune che basa i propri principi sull'accettazione di qualsiasi comportamento, senza pretendere di giudicarlo.
Un posto importante nella produzione cinematografica di Warhol riguarda i cinquecento rulli di Screen Test, film ritratti di personaggi in vista alla Factory che vengono ripresi con camera fissa per tre minuti su un fondo nero. Warhol chiede ad ogni partecipante del provino (screen-test) di fissare la camera, di non muoversi durante la ripresa e di non sbattere le ciglia, restando con lo sguardo fisso.
"Trovo il montaggio troppo stancante […] lascio che la camera funzioni fino a che la pellicola finisce, così posso guardare la persone per come sono veramente."
L'idea di fissare in un ritratto un personaggio che compie un'azione banale, ma che per Warhol ha un importante significato. L'obbiettivo non è solo quello di entrare nell'intimià del personaggio ripreso ma anche quello di colpire lo stesso spettatore, farlo riflettere.
▪ 2002 - Maria Corti (Milano, 1915 – Milano, 22 febbraio 2002) è stata una filologa, critica letteraria, scrittrice e semiologa italiana, una delle voci fondamentali della cultura del Novecento.
Maria Corti, morta prematuramente la madre, visse la sua adolescenza prevalentemente in collegio, mentre il padre ingegnere lavorava lontano, in Puglia. Sotto il profilo affettivo, e in minima parte anche dal lato economico, furono anni difficili. Ciononostante ella trascorse un'adolescenza relativamente serena. S'iscrisse poi all'Università e conseguì due lauree: la prima in lettere con una tesi sul latino medievale (Studi sulla latinità merovingia, relatore Benvenuto Terracini), la seconda in filosofia (relatore Antonio Banfi).
Per impellenti ragioni economiche e anche per la sua passione all'insegnamento, cominciò a lavorare come insegnante di scuola media, prima a Chiari in provincia di Brescia, poi a Como, infine a Milano. Contemporaneamente, svolgeva all'Università di Pavia un incarico di assistente; il continuo spostarsi tra le varie sedi mise a dura prova il suo fisico minuto. La Corti riuscì in qualche modo a superare tutto questo, rivelando un grande carattere supportato da una volontà ferrea.
Nel suo primo romanzo Il trenino della pazienza (pubblicato molto tardi e rimaneggiato nel 1991 con diverso titolo Cantare nel buio), descrive con un linguaggio piano e sommesso ma di grande impatto sociale i suoi continui viaggi da pendolare in terza classe, con gli operai. Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo una partecipazione attiva alla Resistenza col gruppo di allievi di Antonio Banfi, suo secondo maestro, Maria Corti si dedicò con entusiasmo alla carriera universitaria, spinta dallo stesso Terracini (ritornato dal confino dopo la sanzione inflittagli nel 1938 dal regime fascista) a occuparsi di Storia della lingua italiana all'Università del Salento e in seguito all'Università di Pavia, destinata a restare per sempre la sua sede universitaria.
Con alcuni colleghi dell'ateneo di Pavia (Cesare Segre, d'Arco Silvio Avalle, Dante Isella), contribuì a fondare una scuola di studi letterari particolarmente innovativa, denominata Scuola di Pavia, legata alla tradizione filologica ma anche ai nuovi studi semiotici e allo strutturalismo. Maria Corti fondò fra l'altro il Fondo Manoscritti di autori moderni e contemporanei, nell'incredulità del corpo docente e dei collaboratori, supportata solo dalla sua grande volontà e dalla sua sagacia nel reperire i fondi (racconta queste vicissitudini nel libro Ombre dal Fondo, 1997). Un archivio di scritti, manoscritti e appunti vari, donati da scrittori e poeti del Novecento, tra i quali all'apertura nel 1968 Eugenio Montale, seguito da Romano Bilenchi e Carlo Emilio Gadda, attualmente la Fondazione (che in Europa è paragonabile solo al Fondo Marbach presso Stoccarda) è in possesso di scritti di valore immenso e inestimabile: da Mario Luzi a Guido Morselli, da Alfonso Gatto ad Alberto Arbasino, da Italo Calvino ad Anna Banti, da Indro Montanelli a Carlo Levi, da Umberto Saba a Amelia Rosselli, da Giorgio Manganelli a Luigi Meneghello, da Antonio Pizzuto a Paolo Volponi, da Goffredo Parise a Luigi Malerba.
Si dedicò in particolare allo studio della letteratura italiana contemporanea, proponendo un modello di studi con l'edizione critica dell'opera di Beppe Fenoglio (1978). Sono suoi alcuni importanti contributi teorici sulla semiotica letteraria: si ricordano in particolare Nuovi metodi e fantasmi (Bompiani 2001), Principi della comunicazione letteraria (Bompiani 1998) e Per una enciclopedia della comunicazione letteraria (Bompiani 1986).
Tra i romanzi viene ricordato in particolare L'ora di tutti, ambientato a Otranto; contemporaneamente non trascura la sua grande passione per la storia medievale con i suoi saggi su Cavalcanti, Dante, l'aristotelismo latino e l'influsso della cultura araba (Dante a un nuovo crocevia 1981; Percorsi dell'invenzione 1993; La felicità mentale 1983). La Corti non solo si dedicò all'insegnamento, ma per la scuola scrisse diversi libri di testo: fra gli altri, l'innovativa grammatica Una lingua per tutti (1978), che elaborò con alcuni giovani collaboratori; non va poi dimenticato che nel suo dinamismo culturale fu un'accademica della Crusca, fondò e diresse riviste come Strumenti critici, Autografo e Alfabeta e collaborò per un breve periodo al quotidiano la Repubblica. Ricevette alcuni premi: nel 1989 il Premio Flaiano, l'Ambrogino d'oro e il premio speciale per la letteratura della Presidenza del Consiglio, nel 1999 il premio Ministro dei Beni culturali dall'Accademia dei Lincei e, nello stesso anno, il Premio Campiello alla carriera. All'inizio del 2002 ancora attiva e lucida venne ricoverata all'ospedale San Paolo di Milano in seguito a una crisi respiratoria, e il 22 febbraio morì; la salma venne tumulata nella tomba di famiglia a Pellio Intelvi il 25 febbraio.
Opere principali
Narrativa
▪ L'ora di tutti, Milano, 1962;
▪ II ballo dei sapienti, Milano, 1966;
▪ Cantare nel buio, 1981;
▪ Voci del nord-est. Taccuino americano, Milano, 1986 e 2004;
▪ II canto delle sirene, Milano, 1989;
▪ Catasto magico, 1999;
▪ Storie, Lecce, 2000;
▪ La leggenda di domani, Lecce, postumo, 2007.
▪
Saggistica
▪ Metodi e fantasmi, Milano, 1969, nuova edizione ampliata 1997;
▪ I metodi attuali della critica in Italia (in coll. con Cesare Segre), Torino, 1970;
▪ Princìpi della comunicazione letteraria, Milano, 1976;
▪ II viaggio testuale, Torino, 1978 e 1991;
▪ Beppe Fenoglio. Storia di un «continuum» narrativo, Padova, 1978;
▪ Una lingua di tutti, con E. Manzotti e F. Ravazzoli, 1979;
▪ Dante a un nuovo crocevia, 1981;
▪ La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante, Torino, 1993;
▪ Percorsi dell'invenzione. Il linguaggio poetico e Dante, Torino, 1993;
▪ Ombre dal Fondo, Torino, 1997;
▪ Dialogo in pubblico, 1995 e 2001, con bibliografia;
▪ Scritti su Cavalcanti e Dante, Torino, 2003: contiene La felicità mentale e Percorsi dell'invenzione;
▪ La lingua poetica avanti lo Stilnovo. Studi sul lessico e sulla sintassi, 2005.
* 2005 - Luigi Giovanni Giussani (Desio, 15 ottobre 1922 – Milano, 22 febbraio 2005) è stato un sacerdote e teologo italiano, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione (CL).
Ecco la sua biografia, tratta dal sito di Comunione e Liberazione
Luigi Giussani nasce nel 1922 a Desio, un paese nei dintorni di Milano. Da sua madre, Angela, riceve la prima quotidiana introduzione alla fede. Da suo padre Beniamino, appartenente a una famiglia dotata di mano artistica, intagliatore in legno e restauratore, riceve l’invito costante a chiedersi il perché, la ragione delle cose. Don Giussani ha ricordato spesso alcuni episodi della sua vita in famiglia, segni di un clima di grande rispetto per la persona e di attiva educazione a tenere deste le dimensioni vere del cuore e della ragione. Ad esempio, l’episodio che vede lui ancora bambino e sua madre camminare nella penombra dell’alba per recarsi alla messa mattutina. E l’improvvisa sommessa esclamazione di sua madre alla vista dell’ultima stella che brillava nella luminosità crescente del cielo: «Com’è bello il mondo e com’è grande Dio!».
O come l’amore di suo padre, un socialista anarchico, per la musica. Passione che non solo porta quell’uomo a stemperare momenti di difficoltà in famiglia cantando arie celebri, ma a preferire, rispetto ai pochi conforti di una situazione economica modesta, l’usanza, la domenica pomeriggio, di invitare in casa qualche musicista per ascoltare brani dal vivo.
Giovanissimo, Luigi Giussani entra nel seminario diocesano di Milano, proseguendo gli studi e infine completandoli presso la Facoltà teologica di Venegono sotto la guida di maestri come Gaetano Corti, Giovanni Colombo, Carlo Colombo e Carlo Figini.
Oltre che per la formazione culturale e per i rapporti di stima e di viva umanità che intercorrono con alcuni dei suoi maestri, Venegono sarà per Giussani un ambiente importantissimo per l’esperienza di compagnia vissuta con alcuni “colleghi”, come Enrico Manfredini - futuro Arcivescovo di Bologna -, nella comune scoperta del valore della vocazione, valore che si attua nel mondo e per il mondo.
Sono anni di studio intenso e di grandi scoperte. Come la lettura di Leopardi con la quale, racconta don Giussani, soleva talvolta accompagnare la meditazione dopo l’Eucaristia. Si rafforza in quegli anni, infatti, la convinzione che il vertice di ogni genio umano (comunque espresso) è profezia, anche inconsapevole, dell’avvenimento di Cristo. Così gli accade di leggere l’Inno Alla sua donna di Leopardi come una sorta di introduzione al prologo del Vangelo di san Giovanni, e di riconoscere in Beethoven e in Donizetti espressioni vivissime dell’eterno senso religioso dell’uomo.
Da allora, il richiamo al fatto che il vero si riconosce dalla bellezza in cui si manifesta farà sempre parte del metodo educativo del movimento.
Nella storia di CL si può parlare di un privilegio accordato all’estetica, intesa nel senso più profondo, tomista del termine, rispetto all’insistenza sul richiamo di ordine etico. Fin da quegli anni di seminario e di studio, don Giussani impara che senso estetico ed etico provengono insieme da una corretta e appassionata chiarezza circa l’ontologia, e che un vivo gusto estetico ne è il primo segno, come mostrano la più sana tradizione cattolica e quella ortodossa.
L’osservanza della disciplina e dell’ordine nella vita in seminario si coniugherà con la forza di un temperamento che nel colloquio con i superiori e nelle iniziative con i compagni si distingue per vivacità e acume. Ad esempio, Giussani promuove insieme ad alcuni compagni una sorta di foglio interno, intitolato Studium Christi, con l’intento di farne una specie di organo di un gruppo di studio dedicato a scoprire la centralità di Cristo nella comprensione di ogni disciplina.
Ordinato sacerdote, don Giussani si dedica all’insegnamento presso lo stesso seminario di Venegono. In quegli anni si specializza nello studio della teologia orientale (specie sugli slavofili), della teologia protestante americana e nell’approfondimento della motivazione razionale dell’adesione alla fede e alla Chiesa.
A metà degli anni Cinquanta lascia l’insegnamento in seminario per quello nelle scuole medie superiori. Per dieci anni, dal 1954 al 1964, insegna al Liceo classico «Berchet» di Milano. Inizia a svolgere in quegli anni una attività di studio e di pubblicistica volta a porre all’interno e all’esterno della Chiesa l’attenzione sul problema educativo. Redigerà, tra l’altro, la voce «Educazione» per l’Enciclopedia cattolica.
Sono gli anni della nascita e della diffusione di GS (Gioventù Studentesca).
Dal 1964 al 1990 terrà la cattedra di Introduzione alla Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
In più di un’occasione viene inviato dai superiori negli Stati Uniti per periodi di studio. In particolare, nel ’66 trascorre alcuni mesi oltreoceano per approfondire gli studi sulla teologia protestante americana, a cui fa seguito, in edizione accademica, una delle rare pubblicazioni sull’argomento dal titolo Grandi linee della teologia protestante americana. Profilo storico dalle origini agli anni 50.
Guida il movimento di Comunione e Liberazione presiedendone il Consiglio generale.
Presiede inoltre la Diaconia Centrale della Fraternità di Comunione e Liberazione, associazione riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici nel 1982.
Inoltre anima e guida l’esperienza dei Memores Domini, un’associazione laicale anch’essa riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici (1988), che riunisce persone di CL che hanno compiuto una scelta di consacrazione a Dio nella verginità.
È consultore della Congregazione per il Clero e del Pontificio Consiglio per i Laici.
È stato creato Monsignore da Giovanni Paolo II nel 1983 con il titolo di Prelato d’onore di Sua Santità.
È autore di numerosi saggi che sono stati tradotti in diverse lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, ungherese, greco e albanese. Su di essi si sono formati ormai centinaia di migliaia di giovani e adulti.
Dal 1993 dirige la collana «i libri dello spirito cristiano» per una delle più importanti case editrici italiane, la Rizzoli RCS.
Dal 1997 dirige la collana discografica «Spirto gentil» realizzata d’intesa con Deutsche Grammophon, che gode di un notevole successo documentato dai dati di vendita e da numerose recensioni su riviste specializzate.
Nel 1995 gli è stato assegnato il Premio Internazionale Cultura Cattolica.
Nel 2001, in occasione della decima edizione della «Corona Turrita», il riconoscimento voluto dalla città di Desio per i suoi cittadini illustri, viene assegnato il premio a don Luigi Giussani.
L’11 febbraio 2002, in occasione del ventesimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione, Giovanni Paolo II scrive a don Giussani una lunga lettera autografa.
Lo stesso anno, il presidente della Provincia di Milano, on. Ombretta Colli, alla presenza del cardinale Dionigi Tettamanzi, assegna a don Giussani il premio Isimbardi Medaglia d’oro di Riconoscenza, mentre il Comune dei Giovani di Bassano del Grappa conferisce a don Giussani la cittadinanza onoraria.
Nel 2003 don Giussani riceve il Premio Macchi, tributato dall’Associazione Genitori Scuole Cattoliche a chi si distingue nel campo dell’educazione.
Nel 2004, in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita di Comunione e Liberazione, Giovanni Paolo II scrive una lunga lettera a don Giussani, datata 22 febbraio 2004.
Il 16 marzo dello stesso anno, durante la quinta edizione della festa dello Statuto della Regione Lombardia, don Luigi Giussani è premiato con uno dei sedici Sigilli Longobardi assegnati ai cittadini che si sono distinti per particolari meriti sociali.
Muore il 22 febbraio 2005 nella sua abitazione di Milano.
Il 24 febbraio, il cardinale Joseph Ratzinger presiede il funerale nel Duomo di Milano come inviato personale di Giovanni Paolo II, e pronuncia l’omelia davanti a quarantamila persone.
Don Giussani viene sepolto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Successivamente la sua salma viene traslata in una nuova Cappella, sita in fondo al viale centrale del Cimitero Monumentale.
L'elenco sue opere è consultabile al seguente link.
▪ 2009 - Candido Cannavò (Catania, 29 novembre 1930 – Milano, 22 febbraio 2009) è stato un giornalista italiano.
Ha iniziato come giornalista sportivo ne La Sicilia a diciannove anni. Dal 1952 al 1955 ha ricoperto la carica di presidente del CUS Catania. Nel 1955 è stato ingaggiato come corrispondente da La Gazzetta dello Sport. Successivamente è diventato anche inviato speciale e tra le manifestazioni di cui si è occupato si ricordano alcuni Mondiali di calcio, ben 9 Olimpiadi e moltissimi Giri d'Italia.
Nel 1981 è diventato vicedirettore, poi condirettore e nel 1983 è succeduto a Gino Palumbo come direttore responsabile del quotidiano. È rimasto in carica 19 anni, fino al 12 marzo2002, quando è stato sostituito da Pietro Calabrese. Durante la sua carica, la Gazzetta dello Sport si è consolidata come primo quotidiano italiano e maggiore quotidiano sportivo europeo, ha ripreso la pubblicazione del settimanale legato alla Rosea (prima La Gazzetta dello Sport magazine poi Sportweek) e ha aperto il proprio sito web. È stato opinionista (sempre per la Gazzetta) e ha curato le rubriche Candidamente e Fatemi capire. Il figlio Alessandro, anch'egli giornalista, lavora come redattore capo al Corriere della Sera.
Il suo impegno è andato al di là dello sport. Da sempre si è occupato dei problemi della società, soprattutto della sua terra, e da quando ha smesso di dirigere la Gazzetta dello Sport ha pubblicato la sua biografia e tre saggi, che narrano la situazione delle prigioni italiane, dei disabili e dei senzatetto.
Il 22 febbraio 2009, dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni all'ospedale Santa Rita di Milano in seguito ad una emorragia cerebrale, si è spento all'età di 78 anni. In suo onore, nella giornata stessa, su tutti i campi di calcio è stato osservato un minuto di silenzio.
Un mese dopo la sua scomparsa, il 22 marzo 2009 La Gazzetta dello Sport ha deciso di intitolargli sia l'ufficio del direttore (con il nome di "Stanza Candido Cannavò") sia la maglia bianca del Giro d'Italia. La sua tomba è all'interno del cimitero monumentale di Milano Il 2 gennaio 2010 il comune di Castellania (AL) paese natale di Fausto e Serse Coppi nel 50° della morte di Fausto Coppi ha dedicato una piazza a Candido Cannavò
* 2009 - Paul Joseph Pham Ðình Tung (Binh Hoa, 15 giugno 1919 – Hà Nôi, 22 febbraio 2009) è stato un cardinale e arcivescovo cattolico vietnamita.
Ordinato presbitero il 6 giugno 1949, venne consacrato vescovo di Bac Ninh il 15 agosto 1963 dal cardinale Joseph Marie Trinh-nhu-Khuê.
Per quasi tutta la durata del suo episcopato visse agli arresti domiciliari per ordine del regime comunista vietnamita. Gli venne negato di compiere le visite pastorali che il suo mandato richiedeva nelle circa 100 parrocchie della sua diocesi. In seguito alla penuria di preti, formò dei consigli di laici con il compito di muoversi tra le parrocchie per mantenere viva la vita religiosa. Nel periodo di prigionia si mise a tradurre in lingua lục bát la vita di Gesù, i canti gospel e i fondamenti della dottrina divina e della Chiesa.
È stato arcivescovo di Hà Nôi dal 23 marzo 1994 al 19 febbraio 2005, quando venne succeduto dall'arcivescovo Joseph Ngô Quang Kiêt.
Papa Giovanni Paolo II lo innalzò alla dignità cardinalizia nel concistoro del 26 novembre 1994.
Si è spento in data 22 febbraio 2009 all'età di 89 anni.
