GHINASSI A.-MILANESE R., L’eclissi della speranza. Riflessioni sul suicidio e sul lutto di chi rimane
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:
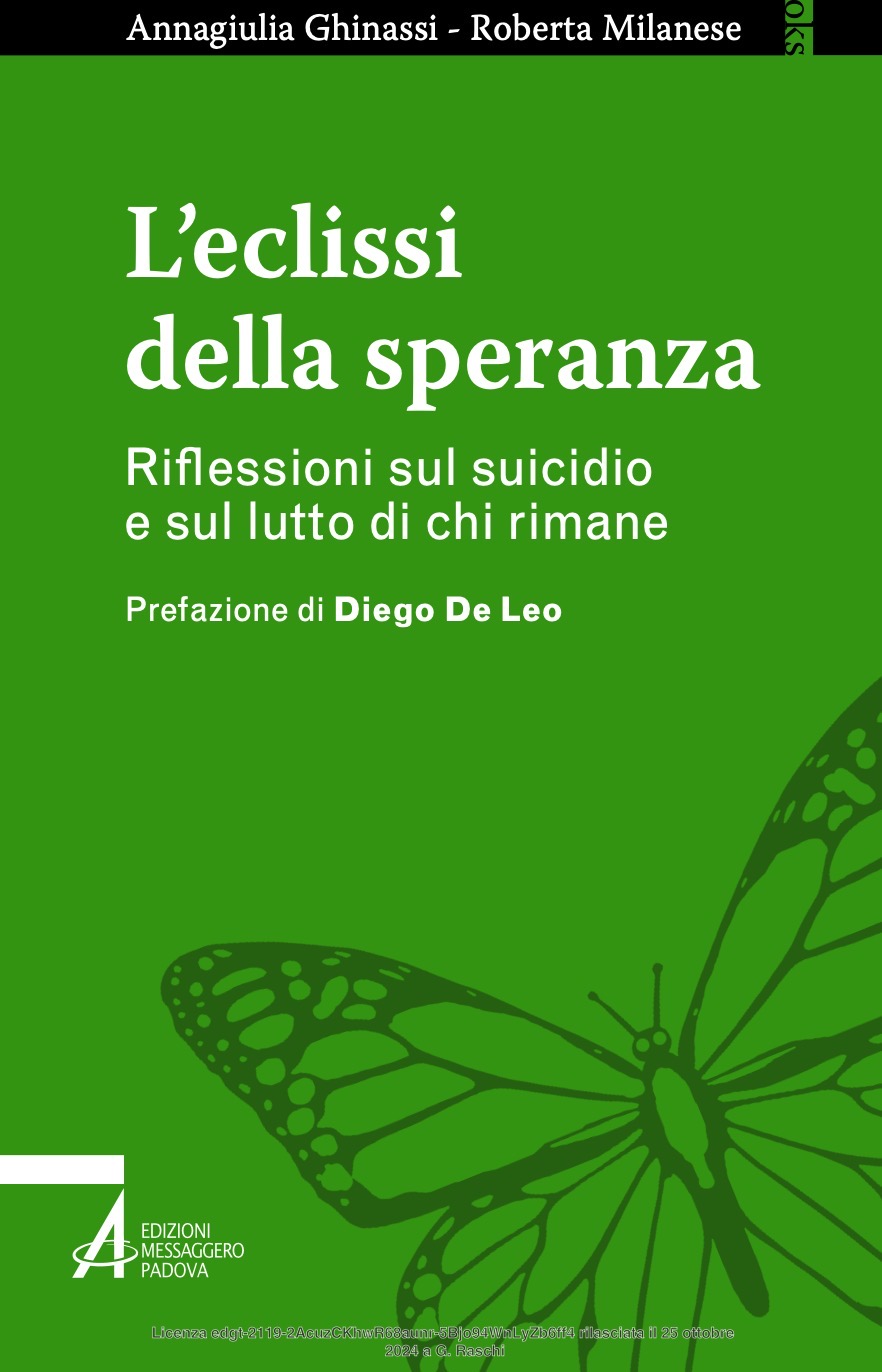
Il libro scritto a quattro mani ed edito dalle edizioni Messaggero di Padova entra a far parte della collana di testi divulgativi “TuttoèVita”, scritti da professionisti della cura della persona, con un’attenzione particolare alla dimensione umana e spirituale.
Degna di attenzione è la prefazione offerta dal Diego De Leo, esperto internazionale nell’ambito dell’analisi del fenomeno del suicidio.
Lo studio che emerge in questo testo offre non solo una riflessione sullo stato dell’arte del suicidio e, sulle cause che possono incentivare questo tragico evento, ma offrono anche lo spunto per riempire di senso la vita di chi ha solo “tentato”. Danno inoltre uno spiraglio di speranza a chi, in seguito ad un suicidio realizzato, rimane qui, vuoto della presenza del proprio caro ma ricco di sensi di colpa devastanti per non aver in qualche modo sventato il tragico evento.
Il testo è suddiviso in cinque capitoli ed è scritto in modo semplice, comprensibile anche dai non addetti ai lavori; allo stesso tempo esprime concetti e riflessioni assai profonde che spronano a una presa di posizione in favore della consapevolezza del valore della vita.
Lo stile dello studio proposto è all’insegna della delicatezza con cui viene affrontato il tema: sensibilità nei confronti di coloro che scelgono la morte come mezzo per liberarsi da una condizione ritenuta troppo pesante, finezza nel prendere consapevolezza delle domande di senso che il suicidio porta con sé quando irrompe nel proprio mondo.
La riflessione degli autori è incentrata principalmente sul tema della speranza.
Essi offrono al lettore un’analisi del fenomeno sociale del suicidio a partire dai dati ufficiali, allarmanti quando riguardano la popolazione degli adolescenti: il suicidio tra i giovani rappresenta una delle prime cause di morte. E questo pur mantenendo chiara la consapevolezza che i dati statistici non fotografano mai in modo certo la realtà, dato quindi che rende maggiormente allarmante la situazione reale; non di rado infatti “molti suicidi vengono disconosciuti e dichiarati come incidenti, per proteggere la persona che si è uccisa e i suoi familiari dallo stigma e da ulteriori conseguenze negative”.
La tesi degli autori, ed anche del sottoscritto, suffragata da una bibliografia consistente (di cui una buona riportata nel volume), rimarca che la maggior parte degli aspiranti suicidi o di coloro che purtroppo sono riusciti nell’intento suicida, di fatto non vogliono morire, bensì vogliono vivere, ma non sanno come placare la sofferenza che li attanaglia. Ecco quindi che il testo ha in sé l’obiettivo di ricercare quella speranza eclissata, che non si riesce più a vedere: la speranza di vivere in modo nuovo.
Le motivazioni per cui la speranza sembra perduta possono essere varie e disparate: dalla sofferenza fisica a problemi giudiziari, da legami affettivi sfilacciati alla morte di un proprio caro, da problemi economici a mutamenti del proprio status sociale, da un brutto voto a scuola alla scoperta di un orientamento sessuale non accettato, dal sentirsi inutile -come spesso accade per l’anziano- al sentirsi di peso per i propri cari. Il suicidio viene visto quindi come un gesto comunicativo, un atto finalizzato a chiedere aiuto perché la vita vissuta in questo modo è percepita come insopportabile.
Ecco quindi che vengono distinte due grandi tipologie di tentati suicidi: quello manipolatorio, dove il gesto è finalizzato alla richiesta di aiuto e non alla volontà di terminare la propria vita, e quello invece in cui il suicidio è messo in atto da chi è veramente intenzionato a togliersi la vita e sopravvive solo per caso. In questa seconda situazione è molto probabile che la persona ritenterà di togliersi la vita ed è proprio qui che l’intervento del terapeuta, degli amici, degli educatori e di chi vive vicino alla persona “fragile” deve essere attivato in modo accurato.
Gli autori evidenziano con maestria che il senso della vita non coincide con l’assenza di sofferenze o di difficoltà, bensì è fondamentale trovare un significato alla propria vita, una direzione verso cui camminare, vivere “per” qualcuno o qualcosa.
Aiutare ed educare i ragazzi a gestire efficacemente le proprie emozioni e i propri fallimenti e aiutare tutti coloro che hanno perso la speranza, sembra essere l’obiettivo del prezioso testo di Ghinassi e Milanese, e per fare questo gli autori offrono anche delle strategie e dei suggerimenti che nascono da una profonda esperienza sul campo.
Altro elemento degno di nota e di pregio nella lettura del testo è il capitolo dedicato alla prevenzione del suicidio; probabilmente è proprio nell’impegno dedicato ad evitare che sorgano desideri di togliersi la vita o pensieri focalizzati a mettere in atto comportamenti finalizzati a procurare la propria morte, che la speranza di poter vivere in modo diverso, senza abbandonare il gioco della vita, raggiunge il più alto grado del suo splendore. La prevenzione del suicidio di un individuo atterrito dalle proprie difficoltà è l’obiettivo principale raggiungibile attraverso la ricerca di senso dell’esistenza.
Una delle modalità più efficaci per attuare la prevenzione in ambito suicidario è quella di contrastare l’idea che il suicidio possa essere un modo accettabile per affrontare le proprie sofferenze; quindi è opportuno “educare i mass media” affinché non propinino ai giovani l’idea del suicidio come modo “normale” per affrontare il proprio problema. Ne abbiamo già visti gli effetti alla pubblicazione del testo di Goethe “I dolori del giovane Werther” dove il suicidio del protagonista per una delusione amorosa aveva causato una sequenza imitativa di suicidi messi in atto con la stessa modalità descritta nel libro.
Gli autori con grande acume pedagogico ed etico suggeriscono a chiare lettere il ruolo positivo che possono e devono avere i mass media nella sfida educativa e nella ricerca della speranza. Quindi non demonizzare lo strumento ma allearsi con esso per testimoniare il valore della vita, sempre!
Infatti anche il silenzio sulla morte e sul lutto, in particolare quando esso è traumatico, per quanto finalizzato ipoteticamente alla protezione dei più giovani, in realtà li lascia drammaticamente soli nell’affrontare l’accaduto. Questo tipo di silenzio probabilmente protegge dall’imbarazzo gli adulti nel parlare di questo argomento, lasciando però un vuoto educativo.
L’importanza del ruolo educativo nella formazione dei giovani che si affacciano sulle complessità del mondo è ormai assodata; gli autori rincarano la dose e argomentano quanto sia necessario e importante riscoprire nella società moderna la cosiddetta “Death Education” che dovrebbe essere declinata attraverso percorsi seri e strutturati sul rapporto con la morte e la finitudine per corroborare gli strumenti di prevenzione dei comportamenti a rischio in generale e suicidari in particolare.
La prevenzione non deve essere finalizzata solo ad evitare che una persona, giovane o adulta che sia, arrivi a mettere in atto un comportamento suicidario; questa è soltanto una sorta di prevenzione primaria. Si parla di prevenzione anche quando si orientano gli sforzi educativi ad aiutare i cosiddetti sopravvissuti, ossia coloro “che vivono un lutto per la morte di una persona amata che si è tolta la vita”; l’aiuto può orientare costoro a riscoprire la speranza nella vita, perché la vita può avere un senso, nonostante tutto. Significativa al tal proposito la citazione riportata di C.S. Lewis: “non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale”.
