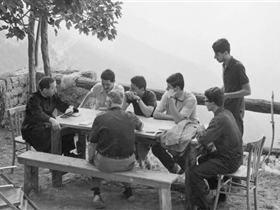Giù le mani dalla nostalgia!
- Autore:
- Curatore:
- Fonte:

Monsignor Mario Delpini è un ottimo arcivescovo di Milano. È attento a tutte le componenti della Chiesa ambrosiana e a tutte le realtà umane e sociali presenti nella città di cui è il pastore; non è divisivo, al contrario valorizza i diversi carismi disseminati nella realtà ecclesiale; e affronta le questioni più delicate con umiltà e rigore. I suoi richiami alla doverosa preminenza della razionalità e della ragionevolezza sull’emotività sono del tutto appropriati ai tempi che viviamo: «In questo momento l’intensità delle emozioni è particolarmente determinante nei comportamenti», ha detto nell’ultimo discorso alla città per la festa di sant’Ambrogio. «Ciascuno si ritiene criterio del bene e del male, del diritto e del torto: quello che io sento è indiscutibile, quello che io voglio è insindacabile (…) La cultura post-moderna esalta l’emozione, lo slogan gridato, stuzzica la suscettibilità e deprime il pensiero riflessivo (…). Ecco: siamo autorizzati a pensare, a essere persone ragionevoli». Ma l’arcivescovo sbaglia quando, come è successo di recente, si unisce al coro di quanti demonizzano la nostalgia. È accaduto in occasione della celebrazione di una Messa in Duomo per l’anniversario della morte di don Luigi Giussani e del riconoscimento ecclesiale della Fraternità di Comunione e Liberazione. Lì mons. Delpini ha criticato, nel corso della sua omelia, l’attitudine di quei ciellini che «vivono nel paese della nostalgia», persi nel ricordo dei tempi in cui le assemblee erano affollate, le feste meravigliose e le vacanze comunitarie un fiorire continuo di nuove amicizie. Per la verità ha criticato anche l’attitudine dei ciellini che ancora vivrebbero nel «paese della militanza», che ha descritto in realtà come l’attivismo di chi ha bisogno di trovarsi impegnato in mille iniziative per sentirsi vivo; ma ciellini siffatti io non ne conosco nessuno da almeno dieci anni a questa parte, e quindi non saprei che dire. Trovo invece ingiusta la criminalizzazione della nostalgia, e non tanto per quanto riguarda Cielle, ma in generale. E vorrei lanciare il monito “Giù le mani dalla nostalgia!”: non quella eventuale dei ciellini, ma quella che da sempre caratterizza molte esperienze degli esseri umani.
Sul bene che è la nostalgia mi ha illuminato tre anni fa Eugenio Borgna, il grande psichiatra e saggista che si è immerso non solo professionalmente ma esistenzialmente nella sofferenza umana, l’ha compresa e in tanti casi l’ha presa su di sé. Avevo letto il suo libro Il tempo e la vita, ed ero rimasto un po’ perplesso della differenza che lui istituiva fra nostalgia e rimpianto. Nel corso di un’intervista gli chiesi di chiarire una delle frasi che più mi avevano colpito e sconcertato: «Nel rimpianto si rimpiange qualcosa che non c’è più, e quello che si rimpiange si cerca disperatamente di cancellarlo dalla memoria, mentre quello di cui si ha nostalgia continua a vivere nella memoria, e a dare un senso alla vita». A me pareva impossibile che qualcosa di definitivamente perduto potesse dare senso alla vita: poteva solo causare tristezza senza fine, e con ciò un depotenziamento della vita. Mi rispose: «Ogni esperienza emozionale complica la vita. Se io vivo senza pensare al mio passato, alle delusioni e ai fallimenti che ho avuto, vivo nel presente senza complicazioni. Ma Agostino ci dice che noi realizziamo una vita dotata di pieno senso soltanto se presente, passato e futuro sono presenti in noi. Se le cose che abbiamo vissuto nel passato e che vorremmo cancellare non rimangono invece con alcune loro tracce anche nel cuore delle esperienze che facciamo oggi, non solo tali esperienze non hanno la pienezza del tempo interiore di cui Agostino parlava, ma senza la nostalgia, cioè senza un presente animato dal passato, noi non siamo nemmeno in grado di vivere il futuro nella sua promessa di pienezza e di grazia. Tant’è vero che Gabriel Marcel ha scritto che la speranza è memoria del futuro. Nella misura in cui noi non perdiamo il significato umano e psicologico, positivo o negativo che sia, delle cose che abbiamo vissuto, noi riusciamo a proiettare nel futuro le nostre aspirazioni più profonde. Le speranze che ci si aprono davanti sono infiltrate dalle esperienze del passato che continuano a vivere in noi. Rimpianti e nostalgie sono sentieri aperti, anche se dolorosi, che rendono il presente più completo e intenso e che ci consentono di avere orizzonti di futuro più ampi e più creativi».
Nostalgia e rimpianto, insomma, hanno entrambi a che fare con la perdita: di una persona cara, di un amore, della salute, di un ruolo importante che si ricopriva. Ma sono due modi profondamente diversi di rapportarsi alla perdita. Nel rimpianto ci si concentra sull’assenza della cosa perduta, e questo provoca quella dimensione patologica della tristezza che è la malinconia. Essere tristi è cosa normalissima, la tristezza è sentimento umanissimo che nasce da una delusione o da una perdita. Diceva Giussani che la tristezza e la stanchezza sono due Grazie che Dio dona: «La tristezza perché mi obbliga alla memoria e la stanchezza perché mi obbliga alle ragioni per cui faccio le cose». La tristezza è patologica quando diventa paralizzante e/o distruttiva, e questa è esattamente la natura della malinconia: una paralisi dell’anima dovuta a una perdita; paralisi che può presentarsi anche come ossessione che conduce a comportamenti distruttivi e/o autodistruttivi. Pensiamo ai terribili, ripetitivi casi di uomini che uccidono le donne che li hanno abbandonati, e a volte uccidono se stessi subito dopo il primo delitto. Il vuoto interiore, lo svuotamento del senso della loro vita prodotto da una perdita che hanno infine realizzato essere irreparabile li sospinge al crimine: mi hai tolto la vita abbandonandomi, non mi lasci altra scelta che pareggiare i conti togliendoti a mia volta la vita. E poi togliendo a me stesso col suicidio una vita che non è più vita. Come cantava Gilbert Becaud nella sua struggente “Et maintenant”: «E ora che farò di tutto questo tempo che sarà la mia vita, ora che tu sei partita? Tutte queste notti per chi, per che cosa? E questo mattino che torna per nulla?».
Più spesso la malinconia - figlia del rimpianto - sfocia nella depressione, dove le ideazioni suicidarie hanno la precedenza su ogni altro genere di aggressività.
Cosa del tutto diversa è la nostalgia: la nostalgia non si concentra sulla perdita in sé, ma sugli effetti che la cosa perduta ha avuto sulla nostra vita. La nostalgia è memoria di un bene sperimentato. E la memoria è una presa di coscienza: prendiamo coscienza di come il bene sperimentato ci ha modellati, ci ha formato nel profondo; di come ci ha resi sapienti: se sappiamo cos’è l’amore, il coraggio, la grandezza d’animo, la cura di sé e l’attenzione all’altra persona, l’amicizia, la lealtà, la paternità, eccetera, è perché ne abbiamo fatto esperienza in un passato che si è concluso. Persone che non ci sono più (magari non perché sono morte, ma perché la loro anima è cambiata rispetto a prima) hanno reso possibile che noi conoscessimo cosa sono l’amore, l’amicizia, la lealtà, ecc. La nostalgia mantiene viva in noi questa conoscenza, e perciò diventa la bussola che ci guida nel presente e verso il futuro: cerchiamo l’amore, l’amicizia, ecc. e li sappiamo riconoscere quando in essi ci imbattiamo grazie alla memoria di ciò che abbiamo vissuto. La nostalgia è la forza propulsiva che ci spinge a fare nuove esperienze ed è il metro di misura che ci fa scoprire la corrispondenza fra ciò che di nuovo incontriamo e i nostri desideri più autentici.
Non me ne voglia mons. Delpini, ma trovo che le persone che non hanno nostalgie e quelle che intimano al prossimo di non avere nostalgie siano delle persone piatte. Herbert Marcuse avrebbe scritto che sono «uomini a una dimensione»: in questo caso la dimensione temporale del solo presente. Perché le persone cerchino di scacciare da sé la nostalgia si può capire: una vita autenticamente umana richiede la compaginazione di passato, presente e futuro; ma il passato implica che qualcosa e qualcuno non ci sia più, sia andato perduto, e questo provoca sofferenza, e la gente oggi non sopporta più le sofferenze emotive: le emozioni devono essere tutte e solo positive. Perché ci siano persone che ordinano agli altri di non avere nostalgie, o che li biasimano affermando che sono dei nostalgici, anche questo non è complicato da spiegare: in genere si tratta di uomini o donne di potere, che ricoprono un ruolo, che hanno preso il posto di qualcuno, che esercitano un’autorità, e vivono il turbamento che la loro autorità non sia adeguatamente riconosciuta, o che sia addirittura contestata, o che l’obbedienza a loro tributata sia pura sottomissione. Sono gelosi di coloro che li hanno preceduti nel cuore delle altre persone: vorrebbero essere amati come coloro che riempiono di nostalgia il cuore della gente, e quando si accorgono che questo non accade, si vendicano accusando chi si mostra distaccato nei loro confronti di essere intrappolato nel passato.
Purtroppo il rifiuto della nostalgia oggi incontra molto successo, perché in tale rifiuto si incontrano il desiderio della maggioranza della gente di non provare la sofferenza che inevitabilmente deriva dal riconoscimento di una perdita e l’interesse dei leader a rimuovere il senso di perdita e a sostituirsi meccanicamente a chi costituisce il bene perduto. La negazione della nostalgia vive di grandi rimozioni: la rimozione della morte di chi ci era caro, della dipartita dell’amato/amata che ci ha lasciati, della fine di una carriera lavorativa, politica, ecc. Molti uomini e molte donne rimpiazzano un amore perduto senza passare attraverso l’elaborazione del lutto affettivo. Spesso la loro “vittima” ci mette un po’ prima di accorgersi di essere quello che nella psicologia si definisce un “oggetto sostitutivo”.
La stessa cosa succede a livelli sociali più complessi, per esempio quando una comunità vive il rapporto con un nuovo leader come se questi coincidesse con la persona del vecchio leader, cioè senza avere elaborato il lutto per la perdita del leader precedente. La sostituzione meccanica, la sovrapposizione delle due personalità come se fossero un’unica persona, come cioè se la morte non ci fosse stata, permette di evitare il dolore per il decesso di chi ci era caro, il senso di perdita e di smarrimento per qualcosa che è finito, per il fatto che le cose non potranno più essere come prima. È per queste ragioni che oggi tanti vedono un nemico nella nostalgia.
Rodolfo Casadei